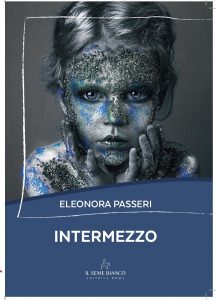L’Associazione Antigone, impegnata nel campo dei diritti e delle garanzie del sistema penale, nata alla fine degli anni ’80 per iniziativa di un gruppo di volontari e che oggi è sostenuta da magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini sensibili al tema, ha pubblicato quest’anno il dodicesimo rapporto sulla condizione carceraria, rapporto denominato con senso di cruda realtà “Galere d’Italia”. Antigone nel corso degli anni è cresciuta ed è diventata il principale punto di riferimento carcerario non solo relativamente alle condizioni di vita all’interno degli istituti ma anche in materia legislativa, col lavoro di predisposizione di proposte di legge e di emendamenti alle leggi in fase di discussione parlamentare. Dal 1998 è autorizzata dal Ministero della Giustizia a visitare gli oltre duecento istituti di pena sparsi sul territorio dello Stato.
Fra le altre cose, per circa venti anni Antigone ha proposto l’istituzione di un “ombudsman” nazionale per la tutela dei diritti dei detenuti; ombudsman letteralmente significa “uomo che fa da tramite”, quindi un garante dei diritti delle persone detenute. Tale garante è stato ufficialmente nominato con decreto del Presidente della Repubblica nel febbraio 2016, ed è Mauro Palma, matematico e giurista nonché primo presidente di Antigone. Visto che in Italia spesso le norme seguono a consuetudini ormai acquisite, prima dell’istituzione del garante nazionale già figuravano diversi garanti comunali, provinciali, e regionali nominati dai relativi organi consiliari. A volte figure effettivamente operative e utili alla causa, altre volte, e più spesso, figure decorative dell’immagine dell’ente locale. In Sicilia per diversi mesi c’è stato un doppio e costosissimo Ufficio del Garante (a Palermo e Catania) privo però di un garante ufficiale, fino a quando il governatore Crocetta, pressato dai militanti Radicali siciliani e dalle associazioni, ad aprile scorso finalmente lo ha nominato. In Campania esiste una garante di nome Adriana Tocco, nominata a febbraio 2011 dall’allora governatore Stefano Caldoro e che, in base alla legge regionale 18 del 2006, avrebbe potuto restare in carica non oltre la fine della legislatura. Attualmente la Tocco risulta ancora in carica. In altre Regioni esiste una legge istitutiva del garante ma a quanto pare si sono dimenticati di nominarne uno…È pertanto evidente come una delle principali incombenze del nuovo garante nazionale sia quella di mettere ordine nel caos regionale di garanti veri e fittizi dei detenuti.
Tornando a “Galere d’Italia”, il rapporto evidenzia che i detenuti, alla data del 31 marzo 2016, sono 53.945, 1.331 in più rispetto al 30 giugno 2015; di questi, circa 9.000 vivono in meno di 4 metri quadrati a testa, il minimo vitale previsto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (nel 2013 la Corte europea dei diritti umani con la sentenza Torreggiani ha condannato il governo italiano). Il tasso di sovraffolamento (numero di detenuti rispetto al numero di posti letto regolamentari) risulta del 108%; lo stesso indice di sovraffolamento è dell’82% in Germania, 85% in Spagna, 97% in Inghilterra e Galles, 118% in Belgio. Un male comune a tutti i sistemi penali europei, con punte molto alte in Belgio, il Paese bersaglio del terrorismo islamico fatto in casa. In Italia i posti letto ufficiali sono 49.545, ma non tutti sono realmente disponibili. Il dato positivo è che negli ultimi sei anni il numero di incarcerati è diminuito di 14.763 unità.
Il tasso di detenzione italiano, circa 90 detenuti ogni 100.000 abitanti, risulta nella media europea; in costante e sensibile diminuzione sono gli ingressi in carcere dallo stato di libertà, 45.823 nel 2015.
A dispetto degli allarmi sociali periodicamente creati da alcuni media e dai soliti gruppi politici giustizialisti, in Italia anche il numero dei reati è in diminuzione, lieve ma costante; omicidi volontari, omicidi colposi, sequestri di persona, violenze sessuali, sfruttamento della prostituzione, furti e rapine fanno tutti registrare un trend decrescente dal 2006 a oggi. Non migliora invece la media dei detenuti in attesa di giudizio, il 35% del totale a fronte di una media europea del 20%. Sono passati quarantacinque anni dal film di Nanni Loy (con la magistrale interpretazione di Alberto Sordi nella parte dello sfortunato geometra Giuseppe Di Noi, premiata con l’Orso d’argento al festival di Berlino, col David di Donatello e il Nastro d’argento), eppure sembra che in Italia la farraginosità della giustizia, la lunghezza imprevedibile dei suoi tempi e la progressiva spersonalizzazione del detenuto siano ancora tratti distintivi del sistema. Peggio di noi, in fatto di imputati detenuti, solo Danimarca e Olanda, il cui ingolfamento dipende soprattutto dalla (eccessiva) severità delle leggi sull’immigrazione.
I principali reati causa di detenzione sono i seguenti: contro il patrimonio (29.913), contro la persona (21.468), droghe (17.676), armi (9.897), associazione mafiosa (6.887). Se si considera che un buon numero di reati contro il patrimonio è collegato a reati di droga, non è difficile capire come la depenalizzazione delle droghe (almeno quelle cosiddette leggere) avrebbe l’effetto di ridurre drasticamente il numero di procedimenti e condanne e quindi la popolazione carceraria. Gli studiosi di Antigone parlano di una riduzione di un terzo dei detenuti nonché di un risparmio per le casse dello Stato di circa 900 milioni d’euro annui, eventualmente utilizzabili per attività socialmente utili e realmente funzionali agli obiettivi di riabilitazione dei tossicodipendenti. Senza considerare il danno che la depenalizzazione delle droghe produrrebbe alle organizzazioni criminali…Ma in Italia questo discorso è proibito dai “moderati” e dagli onnipresenti difensori della famiglia tradizionale, che evidentemente preferiscono un Paese in cui le aziende più floride sono le associazioni criminali a uno in cui il lucrosissimo business delle droghe sia sottratto ai “cartelli” e, accantonata ogni amenità proibizionista, trasformato in mercato legale, controllato, regolato e tassato.
Gli stranieri detenuti rappresentano circa il 33% del totale, a fronte di una media europea del 21%. In Italia quindi vi è una sovra-rappresentazione della categoria, in parte dovuta alla legge Bossi/Fini e in parte dovuta a una ricorrente discriminazione che subiscono gli imputati stranieri nell’applicazione delle misure cautelari (il 42% degli stranieri detenuti è in attesa di giudizio). Il 70% degli stranieri deve scontare una pena residua inferiore a tre anni, tale da consentire l’accesso a una misura alternativa, ma anche in questo campo si registrano forti lacune del sistema, anche dipendenti dalle difficoltà degli stranieri nel trovare un domicilio, comunque necessario per fruire dell’affidamento in prova ai servizi sociali, della detenzione domiciliare o della libertà vigilata (che tecnicamente è una misura di sicurezza non detentiva).
L’indicazione geografica dei detenuti italiani, invece, non presenta sorprese…La prima in classifica è stabilmente la Campania, col 18,5% del totale dei detenuti, seconda la Sicilia col 12%, terza la Puglia col 7%. Campania, Sicilia e Puglia, tre regioni “madri” della criminalità organizzata; un’altra madre, la Calabria, è quarta in classifica. Le donne incarcerate sono poco più di 2000, ovvero il 4% della popolazione ristretta, a fronte di una media europea del 5,6%. I minori detenuti sono circa 450, di cui una quarantina di ragazze; in proposito è molto significativo il dato 2016 relativo agli ingressi di minori, di cui meno della metà sono italiani. In pratica nel 2016 in corso stanno entrando nel circuito penitenziario più minori stranieri che italiani.
Circa 30.000 i condannati in misura alternativa. Di questi più di un terzo sono in detenzione domiciliare, poco meno di un terzo in affidamento in prova ai servizi sociali mentre in forte contrazione è la semilibertà. Confermando le teorie scientifiche in materia, la recidiva del reato durante una misura alternativa è vicina allo zero (0,79%).
La nuova misura della messa alla prova per gli adulti, introdotta nel 2014 e applicabile agli autori di reati non gravi o comunque puniti con reclusione inferiore a quattro anni, è in provvidenziale aumento e ha evitato un ulteriore sovraffollamento degli istituti (dai 2 beneficiari del 2014 ai 7.818 del 2015 e 2016, oltre ai circa 10.000 sotto indagine dei servizi sociali in funzione della decisione giudiziaria).
I permessi premio, altro ciclico tormentone di quei soliti media pescatori nel torbido, nel 2015 sono stati 29.224, di cui quasi 10.000 nella sola Lombardia grazie al “modello Bollate”. Quindi, in rapporto al numero di detenuti “regionali”, 156% in Lombardia (più di un permesso e mezzo a detenuto), 79% in Emilia Romagna, 71% in Toscana.
Per quanto concerne “la vita dentro”, quasi tutti i detenuti (il 95% del totale) possono trascorrere le otto ore previste dalla legge al di fuori della cella. Il problema è che queste ore troppo spesso diventano “oziose”, fino a indurre molti detenuti a non usufruirne. Il cosiddetto diritto all’affettività è solo parzialmente garantito: 123 istituti consentono ai familiari di prenotare le visite (76,6% di attuazione della legge), 98 istituti consentono visite sei giorni alla settimana (50,7% di attuazione della legge), 172 istituti offrono spazi per i bambini figli di detenuti (89% di attuazione della legge), 146 istituti consentono agli ospiti una telefonata settimanale di dieci minuti ai familiari (75,6% di attuazione della legge), 2 istituti consentono telefonate via internet.
Solo 111 istituti hanno provveduto a elaborare un proprio regolamento interno per i detenuti e il personale, gli altri 82 istituti ancora non l’hanno fatto. Sicuramente insufficiente il numero di mediatori culturali.
In diminuzione il numero di suicidi in carcere, 43 nel 2015, così come i decessi naturali, grazie al miglioramento delle condizioni logistiche e sanitarie conseguenza del minore affollamento. Anche i suicidi di agenti di polizia penitenziaria, ben 11 nel 2014, si sono quasi azzerati (2 nel 2015). Un carcere più umano, con ogni evidenza, risolve molti problemi.
I detenuti lavoratori sono circa il 30%, ma quasi tutti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria in attività interne. Il lavoro in carcere non impegna il singolo detenuto oltre le 10/15 ore settimanali per 200/250 euro mensili.
I detenuti studenti, nel corso dell’anno scolastico 2014/2015, sono stati ufficialmente 17.096 (quelli iscritti), di cui meno della metà quelli veramente frequentanti la scuola e poco più di 7.000 i promossi alla fine dell’anno. 72 detenuti si sono laureati nel 2014.
I detenuti in regime di alta sicurezza, a maggio 2015, erano 8.886, di cui 721 in “41 bis”.
La spesa per le carceri è progressivamente aumentata fino al 2013, quando lo Stato ha speso oltre 3 miliardi d’euro. Da allora è leggermente diminuita, e il bilancio preventivo per il 2015 indicava 2,7 miliardi. A smentita di altra vulgata, va detto che oltre l’80% del bilancio del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) è assorbito dalle spese di personale, mentre le spese per i detenuti assorbono meno dell’8%. Raffrontando la spesa carceraria italiana con quella di altri Paesi, segnatamente Francia, Spagna e Inghilterra-Galles, il costo giornaliero in Italia è il più alto, pari a 141, 80 euro; in Francia 100,47 euro, in Spagna 52,59 euro, in Inghilterra-Galles 109,72 euro. Eppure, fra i quattro Paesi, abbiamo il minor numero di detenuti, ma il maggior numero di personale dipendente…
Molto interessante la parte del rapporto dedicata ai reparti psichiatrici giudiziari degli istituti penitenziari italiani, che ospitano quei detenuti sospettati di infermità psichica e da tenere sotto osservazione per almeno trenta giorni consecutivi. Infatti, a seguito della progressiva chiusura degli OPG (che dal 31 marzo 2015 dovrebbero essere chiusi per legge. Ad oggi, però, solo quello di Napoli ha realmente cessato l’attività), il ruolo di questi reparti diventa cruciale. La stato dell’arte attuale è molto confuso, soprattutto sul piano normativo visto come, in assenza di procedure codificate, le assegnazioni dei ristretti a questi reparti (che non di rado diventano OPG mascherati) non sempre vengono vagliate dalla magistratura e a volte neanche dal personale sanitario del carcere, dipendendo esclusivamente dall’amministrazione. Oltre alle precarie condizioni strutturali di molti reparti, gli osservatori di Antigone hanno rilevato la presenza di sistemi di contenzione ormai fuorilegge, su tutti il famigerato “letto di contenzione”. Il quadro poco edificante illustra inoltre una diffusa insoddisfazione del personale, che solo in pochi casi riceve formazione specifica, con inevitabili e frequenti casi di “burn out”. Solo nei casi più virtuosi (e che eccezionalmente virtuosi non dovrebbero essere) viene garantita assistenza medico-infermieristica continuativa (h24), e gli stessi operatori lamentano una scarsa o nulla collaborazione con i Servizi di salute mentale del territorio.
Il rapporto si chiude con le proposte di Antigone per il miglioramento e l’umanizzazione del sistema carcerario.