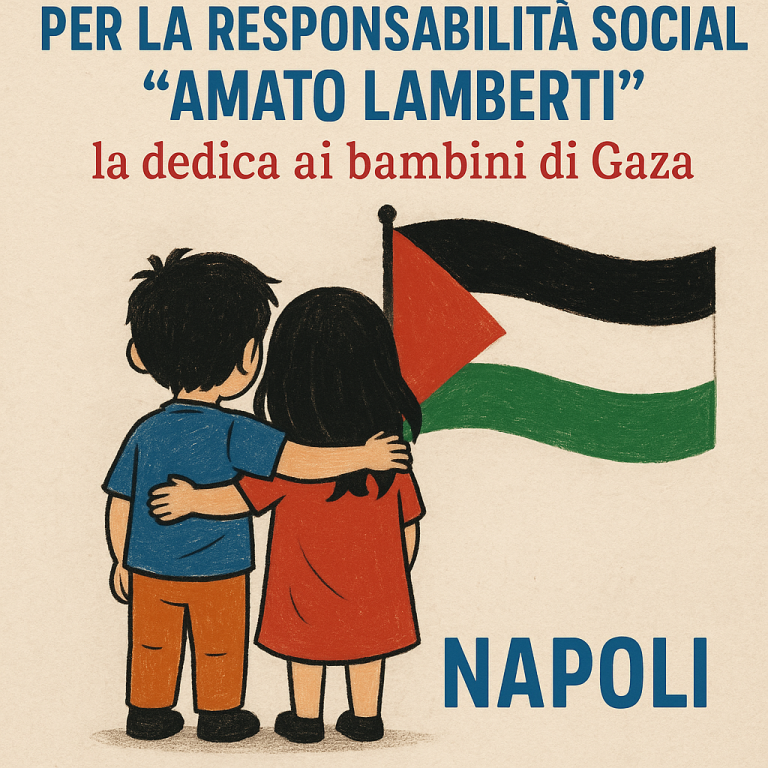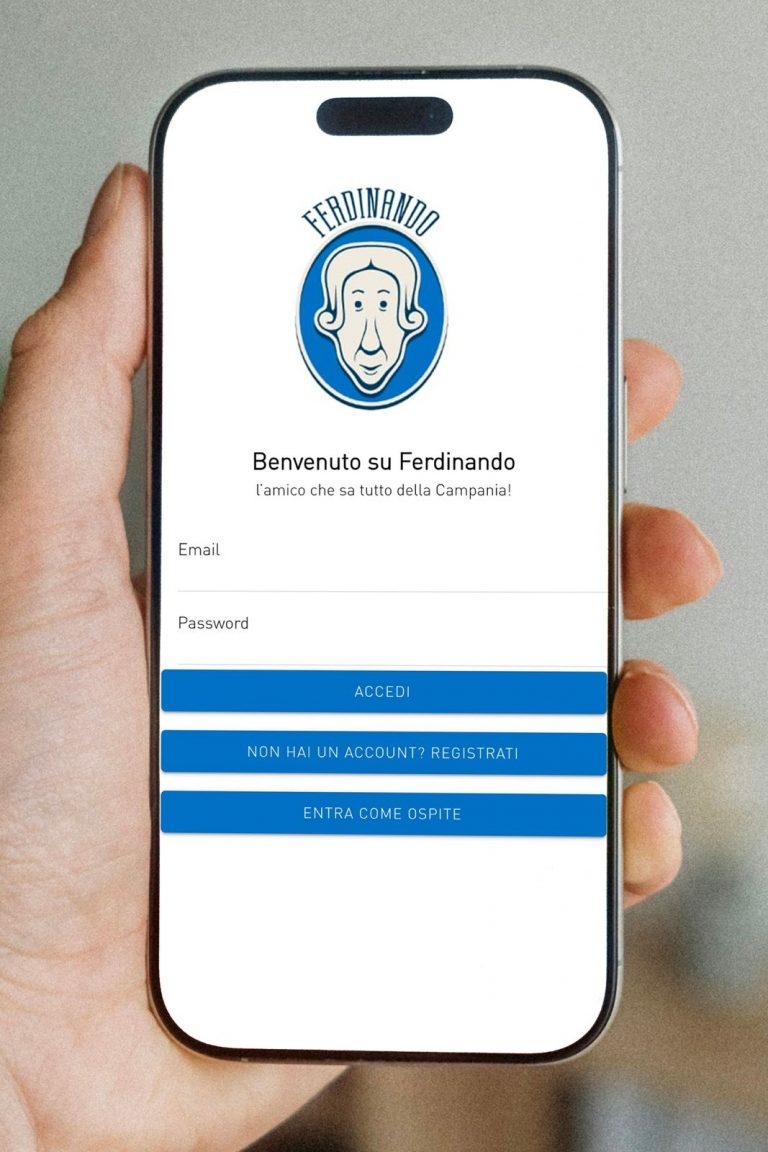L’evento atteso da tempo e paventato soprattutto da molti osservatori esterni è infine accaduto. Il colpo di Stato in Turchia, attuato dalle forze militari nella serata del 15 luglio 2016 ma fallito dopo quattro ore, può essere certamente descritto come conseguenza del definitivo distacco di Erdoğan dalla società civile. Un frattura insanabile derivante dalla costruzione di una democrazia “controllata”, ostile alla stampa ed a qualsiasi forma di dissenso. Negli ultimi 14 anni, la Turchia si è mostrata al mondo come un paese lacerato nei rapporti interni ed esterni e con profonde divisioni: basti pensare al comportamento ostile del governo nei confronti dei propri militari considerati da sempre difensori della laicità dello Stato. Il paese della mezzaluna, dunque, ha provato a resistere all’ondata islamica in virtù dei solidi principi di democrazia tramandati di generazione in generazione dai tempi di Atatùrk ma la virata di Erdoğan nella costruzione di un potere dispotico ha creato profondo disagio nella popolazione . Se si aggiunge la crisi con la Russia, generata dall’abbattimento del jet militare russo ad opera di Ankara, si spiega l’isolamento nazionale ed internazionale  della Turchia. Sventato il colpo di Stato guidato dai colonnelli dell’esercito, il governo turco si prepara ora ad un lungo e duro giro di vite contro i golpisti e chi li ha sostenuti mentre il Presidente Recep Tayyip Erdoğan, tornato trionfatore ad Istanbul dopo l’appello alla resistenza, valuta il ripristino della pena di morte quale strumento per garantire la stabilità di un paese in cui i diritti sociali e civili sono stati da tempo annullati e sottratti ai singoli cittadini. Cosa faranno gli alleati occidentali in attesa di un difficile ripristino della legalità in terra turca? E’ ancora possibile garantire stabilità nel vecchio continente in una fase storica complessa e dall’equilibrio precario? In attesa di risposte, nella notte più lunga vissuta dalla Turchia nell’ultimo ventennio si contano i primi 190 morti oltre che 1300 arresti.
della Turchia. Sventato il colpo di Stato guidato dai colonnelli dell’esercito, il governo turco si prepara ora ad un lungo e duro giro di vite contro i golpisti e chi li ha sostenuti mentre il Presidente Recep Tayyip Erdoğan, tornato trionfatore ad Istanbul dopo l’appello alla resistenza, valuta il ripristino della pena di morte quale strumento per garantire la stabilità di un paese in cui i diritti sociali e civili sono stati da tempo annullati e sottratti ai singoli cittadini. Cosa faranno gli alleati occidentali in attesa di un difficile ripristino della legalità in terra turca? E’ ancora possibile garantire stabilità nel vecchio continente in una fase storica complessa e dall’equilibrio precario? In attesa di risposte, nella notte più lunga vissuta dalla Turchia nell’ultimo ventennio si contano i primi 190 morti oltre che 1300 arresti.