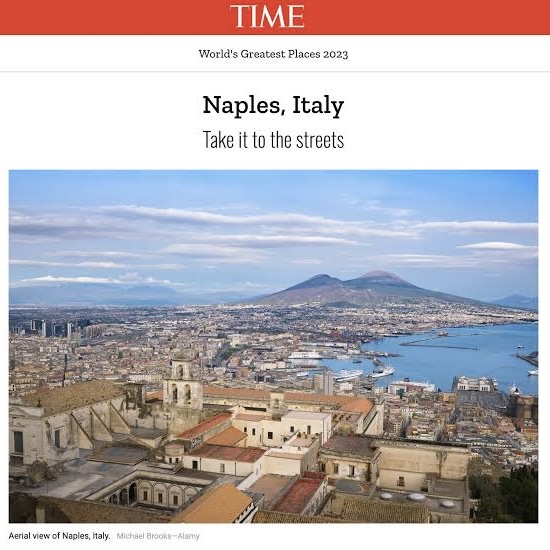Si è tenuta venerdi 2 dicembre al “Tallioo“ di San Giorgio a Cremano la presentazione del libro “La mia unica certezza è forse“, edito da Book Sprint e scritto da Nevio De Stefano, docente di matematica e fisica, nonché valente conoscitore delle stesse. L’autore vanta all’attivo un’esperienza in politica in qualità di assessore alla pubblica istruzione, un saggio sulla didattica della fisica e diversi convegni sul tema.
La fisica quantistica ha rappresentato una vera “Rivoluzione copernicana”. Si è passati da una visione dell’universo scontata e quasi rassicurante, un sistema causativo e prevedibile ad una concezione probabilistica della realtà. Tutto ciò non poteva non influenzare ogni campo: dalla letteratura alla filosofia. Le cose non hanno alcuna sostanza ma esistono in relazione alla loro influenza sulle altre, e ciò significa dire che la realtà è variegata, mutevole, scoordinata, imprevedibile. Non ci sono certezze, verità assolute. In filosofia lo affermò il grande nemico della metafisica: Friedrich Nietzsche, in letteratura uno dei più grandi scrittori e pensatori del mondo, forse un po’ sottovalutato: Luigi Pirandello. Il suo teatro fa storia a sé; i suoi personaggi, sdoppiati, tormentati, estranei a loro stessi come “Lo straniero” di Camus, personaggi che abitano in molti il sottosuolo di Dostoevskij, che usano la maschera per nascondersi ma anche per vedere al di là del loro nascondimento, fanno parte del nostro inconscio collettivo.
E’ proprio sul parallelismo tra fisica e letteratura che verte il libro; conosciamo meglio l’autore.
- Nevio, il contrasto tra la vita, la “Nostra vera sostanza” e la forma, cioè il modo in cui ci mostriamo agli altri, crea un dualismo inconciliabile ed una vera destrutturazione del soggetto, dell’Io, ridotto a frammenti e scoordinato. Se è vero che la fisica quantistica ha sostituito il determinismo con il probabilismo, e che Pirandello rappresenta un fenomeno rilevante di relativismo culturale, qual è il debito che entrambi hanno nei confronti del filosofo Artur Schopenhauer e della sua teoria della doppia soggettività?
“Direi che il saggio può essere permeato del pensiero di Schopenhauer, tuttavia sono consapevole di non aver spinto la mia ricerca fino a quest’ennesima riflessione: tentare di produrre un libro fruibile a tutti e non solo agli “Addetti ai lavori” mi ha necessariamente costretto ad eludere una serie di collegamenti logico-filosofici che tu hai individuato alla perfezione. Il dualismo cui accenni è presente, seppur in maniera marginale, per Heisenberg nella forma, e per Pirandello quando afferma che la vita “O la si vive o la si riflette”, ciò che io nel libro definisco “Principio di indeterminazione”. Probabilmente se avessi scritto un saggio su Leopardi avrei potuto spingermi molto di più su Schopenhauer; ad ogni modo, il solco di quest’opera sfiora vagamente la teoria del filosofo di Danzica, con l’obiettivo di aprirsi e riprendere quei collegamenti che ho dovuto recidere sia per ragioni di pubblicazione che di utenza: se lo avessi reso eccessivamente pletorico sarebbe diventato stucchevole e di difficile comprensione.
- Il grande tema della “Maschera” ci riporta dunque al rapporto tra essere e apparenza, e al dualismo di cui ho poc’anzi parlato. Il filosofo Friederich Nietzsche affermava che ogni cosa profonda possiede una maschera. I personaggi di Pirandello indossano maschere e si rendono conto di non essere liberi. Nietzsche ritiene la civiltà della maschera l’approccio più significativo alla riflessione filosofica, dai Greci fino all’oltreuomo. Potremmo affermare che Nietzsche con il suo nichilismo è decadente, con il suo classicismo e la sua “Volontà di verità” non lo è. Ritieni questo parallelismo tra il grande filosofo e Pirandello pertinente al tuo libro?
“L’influenza nietzschana entra a gamba tesa nel Decadentismo italiano, anche se solitamente sui libri scolastici vige un malsano accostamento tra lo “Übermensch“, l’Oltreuomo, ed il “Superuomo” dannunziano: Nietzsche per il suo profilo persuade moltissimo le maschere di Pirandello, con un importante dettaglio, mentre Pirandello fa un’affermazione più sconvolgente, ricordando che “Dentro la maschera non vi è nulla”; Nietzsche non arriva a fotografare tratti di individui dietro i quali vi è il nulla, però tutte le maschere di Pirandello potrebbero aver subito una grande influenza del filosofo tedesco.
- La realtà, secondo la fisica quantistica, è definita rispetto al suo osservatore, non esiste dunque una realtà oggettiva ma tante realtà diverse. Pirandello affermava che essa (Realtà) “Non ci fu data e non c’è, ma dobbiamo farcela noi se vogliamo essere”. Nietzsche affermò che la realtà esiste, che non dobbiamo cercare nessuna cosa in sé, ma essa richiede tante interpretazioni quante sono le prospettive. Non credi che tutto ciò abbia cambiato il mondo e portato ad una totale sfiducia sia nei progressi scientifici e nell’uomo in generale?
“Certo, tale considerazione si innesta perfettamente nella nuova visione scientifica figlia della seconda metà del Novecento, ovvero quella che fino ad allora era considerata “Oggettività”; oggi, per ammissione di tutte le comunità scientifiche del mondo l’oggettività non è altro che l’intersoggettività: se tutti concordiamo nel descrivere un fenomeno in un determinato modo, il fenomeno verrà descritto in quella maniera, ma non possiamo ammettere che esiste un verbo assoluto. Il senso di sfiducia a cui tu alludi, inequivocablile in letteratura, entra fortemente e pesantemente in fisica con la meccanica quantistica, ed ancor peggio viene demolito un caposaldo, che l’analisi matematica è atta a descrivere tutto. Di conseguenza, scende in campo la probabilità, ottimo strumento per descrivere quello che può accadere.
- Pirandello e il suo relativismo fondamentalista, il suo credere che la realtà sia apparenza, le sue maschere e i suoi personaggi problematici mi riportano un po’ alle filosofie orientali ed al buddismo. Pensiamo a “Il fu Mattia Pascal” ed allo sdoppiamento di Mattia, il protagonista, che non esiste come “Ente” ma ha bisogno di essere “Riconosciuto” dagli altri. Questa affinità con l’Oriente, anch’essa, ci ricorda la fisica quantistica, la scoperta della Teoria dei Quanti, cioè che la proprietà delle cose non è altro che il modo in cui esse si rapportano, influenzandosi tra di loro. Non trovi sia anche questo un filo che unisce Heisenberg a Luigi Pirandello?
“Sui due soggetti in senso proprio non c’è un netto legame, poiché specialmente Heisenberg non ebbe durante la sua vita contatti con la filosofia orientale, un pò per il profilo, un pò perché non si spostò mai dall’Europa nè dalla Germania; egli era di fede fortemente luterana, dunque non allargava gli orizzonti della sua quotidianità; soltanto in ambito scientifico fu devastante. Su Pirandello non posso fornire una fotografia così stretta e definita, poiché l’uomo Luigi Pirandello aveva una cultura eminente che abbracciava non tutta l’Europa, bensì tutto il mondo, difatti egli è riconosciuto a livello internazionale. Non dimentichiamo che anche politicamente quando Pirandello cadde in disgrazia in Italia venne difeso solo dal prestigio che gli fu attribuito in Germania.
- Il Decadentismo sappiamo che fu un’importante corrente letteraria che ebbe per estremi anche i “Crepuscolari”, i Poeti maledetti, D’Annunzio, e rappresentò una vera e propria rivolta contro l’ottimismo positivista e rispecchiò il nuovo clima culturale nel periodo tra fine Ottocento e inizi Novecento. Einstein e la Teoria della relatività, con il tempo che diviene una “Quarta dimensione”, Heisenberg e il principio di indeterminazione, Freud con il suo inconscio che relegava l’IO cosciente a puro accessorio, Henri Bergson che contrapponeva la vitalità dell’esistenza al freddo calcolo e alla ragione del positivismo, e Luigi Pirandello e il suo radicale relativismo, il suo rifiuto delle certezze, dei ruoli, delle regole, il suo rifugio nella follia, nell’irrazionale. Oggi viviamo nell’età della tecnica, nel grado più alto di razionalità raggiunto dal mondo, in cui l’uomo è ridotto a puro funzionario di apparati tecnici. In questo scenario vi è ancora posto per il pensiero “Contro” di Pirandello, per un Umanesimo che ricerca di senso e bisogno di introspezione? In un mondo di uguali, di omologati, e in cui le persone sono ridotte a schiere di consumatori, vi è ancora spazio per “Uno, nessuno e centomila?” Mattia Pascal sarebbe un uomo qualsiasi e l’oltreuomo di Nietzsche ridotto a prodotto subumano dove potrebbe oramai andare?
“La società attuale è figlia di una reazione totalmente opposta (per citare il terzo principio della termodinamica), reagisce all’ondata di irrazionalità: tu hai citato Bergson, che parla dell’intuizionismo; anche in matematica esiste l’intuizionismo: Brouwer definì la matematica “Intuizionismo”. Questo terremoto dopo aver sconvolto tutti i livelli della cultura novecentesca vide una reazione: qual è una reazione che dà certezza alle persone? Un ipertecnicismo: non mettere più il sapere in collegamento, scinderlo, e far formare il prossimo in unico ambito. Una grande reazione culturale, dunque, di carattere conservatore, che rende gli altri ipertecnici, preparatissimi, senza però osservare dalle diverse angolazioni. Il drammaturgo Prosperi, attore scomparso, in un celebre film dal titolo “La scuola” incarnò questo ruolo in un preside ipertecnico ignaro del fatto che la Morante si chiami Elsa, dell’inesistenza di un film su “La metamorfosi” di Kafka. E’ questo il concetto di ipertecnico: chi svolge esclusivamente il suo lavoro senza mai guardare al di là degli orizzonti ed incapace di connettere i vari universi del sapere.
Grazie per il tuo libro e per queste riflessioni così illuminanti, ma soprattutto per questo accostamento straordinario. Complimenti vivissimi, a nome di tutta la comunità culturale.