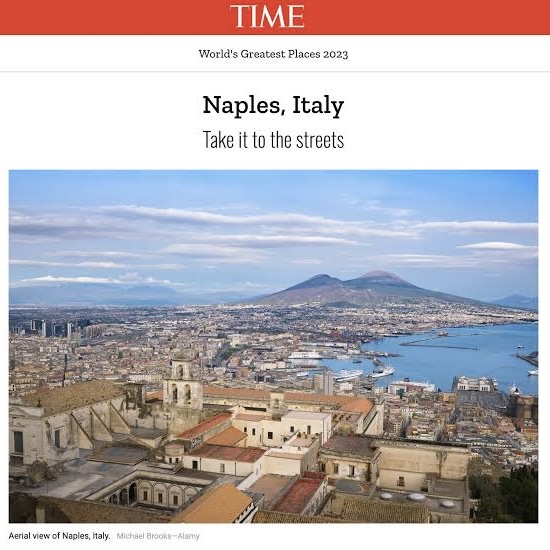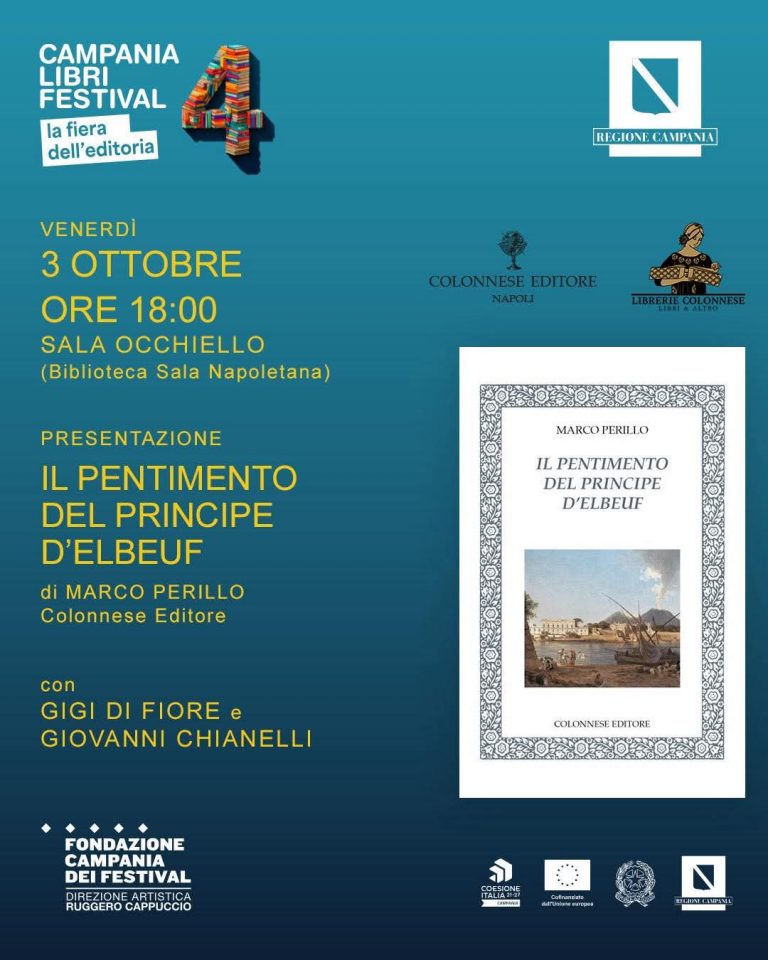Feriae Augusti: Giorni di riposo di Augusto (da cui Agosto) Già nell’antica Roma i giorni di metà agosto erano giorni di vacanza, di riposo, di meritato deboscio. E sì che i romani antichi sapevano debosciarsi alla grande…Che poi il termine “feriale”, che ha la stessa derivazione latina, significa giorno lavorativo dipende dal calendario liturgico, secondo il quale ogni giorno della settimana è “feria”, salvo il sabato e la domenica. Le ferie antiche sono diventate festività con l’affermarsi del cristianesimo, che ne ha inserite molte nel calendario liturgico, spesso cambiandone il nome e legandole all’occorrenza di avvenimenti religiosi. La tradizione popolare ha fatto propria la festa e l’ha fatta diventare un momento alto di aggregazione sociale e comunitaria, accompagnando al rito religioso spettacoli laici e di divertimento collettivo. E’ il caso del ferragosto avellinese, “ferrausto” in avellinese antico ma non ancora in disuso, in cui la festività è dedicata alla madonna Assunta. Già una ventina di giorni prima del 15 agosto, il 26 luglio giorno di Sant’Anna, viene esposto al loggiato del vescovado cittadino il “pannetto”, un antico drappo celeste con l’immagine della madonna. Nel pomeriggio del 15 si svolge la processione per le strade della città, rito religioso e laico insieme, in cui una statua della madonna Assunta viene trasportata, una volta a spalla ma oggi su una macchina scoperta, tra due ali di fedeli, con a capo il vescovo, seguito in ordine rigorosamente gerarchico dalle autorità civili e religiose e da una grande folla variopinta e ciangottante, fatta non solo di avellinesi di città ma anche di molti abitanti della provincia irpina. Fino a una ventina di anni fa (o forse più), ogni avellinese emigrato, in Italia e anche all’estero, si faceva un punto d’onore la partecipazione alla processione dell’Assunta, organizzando le proprie ferie per essere presente in città nei giorni della festa. Oggi i figli ormai adulti di queste persone appartengono alle città e ai luoghi dove sono cresciuti e dove vivono, e preferiscono vacanze altre rispetto al ferragosto avellinese. Anche i giovani e giovani adulti avellinesi attuali cominciano a snobbare la festa e i suoi riti, attirati dal turismo di massa e dalla smania del ferragosto più trendy a mare, all’estero o in qualche sarabanda alcolica travestita da fiera. Questi ragazzi magari alimenteranno il pil, ma pure l’aridità sociale di una generazione che sta lavorando forse inconsapevolmente per essere sempre più settaria e individualista. Spiace dirlo, ma la recente sinistra cittadina ha grandi responsabilità nello “snobbamento” della festa più popolare, ha grandi colpe nell’abbandono delle masse lavoratrici (come si diceva giustamente una volta) nei suoi momenti collettivi più sentiti. Non è semplice folklore del Sud, come qualcuno ha liquidato la festa. Il partito rivoluzionario può anche prendere le distanze dalle manifestazioni pagane del popolo adorante un simbolo della sua sottomissione, non per questo può permettersi di disprezzare quel popolo. In fin dei conti si tratta di quel popolo che giustifica e legittima l’esistenza di un movimento di cambiamento, che legittimerebbe quindi i portatori di cambiamento e la loro compiaciuta diversità. Oggi più che mai non abbiamo bisogno di radical-chic, ma solo di radical. Dentro le cose e i fatti della gente, non fuori a fare l’avanguardia senza avanguardisti. Avanguardia giovanile, peraltro, ormai standardizzata a sua volta, irreggimentata in rumori elettronici e schiava di dj set. Il ferragosto avellinese invece e a dispetto del delirio consumistico, era un avvenimento unico, di tradizione vera, e lo rimane pur con tutta la recente concorrenza di sagre, nomepaesearte e inviti alla sbronzate (e stronzate) in giro per la provincia. Il ferragosto del popolo, proprio nella sua accezione più autentica e proletaria. Un popolo che riesce ancora a essere tale al seguito della sua madonna, madre di Gesù ma soprattutto madre consolatoria del suo stuolo di disgraziati che non a caso la invocano spesso e irrispettosamente tutti i giorni. A ferragosto si va alla processione e tutti i peccati di parola del popolo cafone si mondano di giustizia popolare e di condiscendenza religiosa. La religione è l’oppio dei popoli ma, senza alternative valide, anche la sua ancora di salvezza. La madonna Assunta e i suoi sacerdoti assolvevano (e assolvono) un’intera provincia dalle maledizioni dovute a secoli di miseria e di sfruttamento. E in più davano speranza, a un popolo che nonostante tutto aveva deciso di difendere i valori democratici e che mandava i figli a scuola. Lontani comunque i tempi in cui pullman di linea scaricavano dai paesi limitrofi decine di migliaia di persone, che casomai venivano in città solo quella volta in tutto l’anno, “po’ ferrausto”, obbligando autisti sudatissimi e abilissimi nel loro lavoro a fare servizio notturno e continuativo. Lungo il corso Vittorio Emanuele, la carrozzabile sconnessa e scura della città non ancora lastricata di bianco, si teneva la chiassosa fiera delle bancarelle, dove si poteva acquistare di tutto, dal formaggio di pecora alla catenina d’oro a pochi carati. Oggi la fiera esiste ancora, ma motivi igienici e di presunto decoro urbano l’hanno di fatto ghettizzata in periferia, rendendola niente più che un mercato rionale. La festa civile iniziava il 13 agosto, con un circuito ciclistico dilettantistico a cui partecipavano anche ciclisti del centro e del nord Italia. Qualche corridore passato per Avellino è anche diventato professionista. Un parente di chi scrive, verso la fine dei ’70, è arrivato secondo, battuto allo sprint da tale Guido Bontempi, non ancora ciclone. A causa di sempiterni lavori stradali, per diversi anni la corsa di biciclette è stata accantonata, quest’anno è ripresa. Non mancavano, e non mancano anche oggi, le bancarelle di torrone (quello irpino è fra i migliori d’Italia) e di altre leccornie come “le castagne del prete”. La città, ancora quando chi scrive era un ragazzino, si impregnava di odori di frittura provenienti dai chioschi e dai loro panini untissimi, di castagne e nocciole abbrustolite, mentre la gente cercava riposo e refrigerio sulle sedie davanti ai bar del centro, straordinariamente affollati ma col listino prezzi ordinario. Noi ragazzi andavamo alle giostre in cerca di sguardi nuovi e di avventure coraggiose. Ci vorrebbe la penna di un Raffaele Viviani, e non quella del modesto scriba, per descrivere le resse, i suoni, gli odori, i rumori e i chilometri a piedi del ferragosto avellinese (d’altronde fra le opere di Viviani c’è “La festa di Montevergine”, altra festività irpina molto conosciuta a Napoli). Oggi chi viene da fuori viene per forza in macchina, pochi azzardano un dolce da bancarella a quelli da supermercato. Molti odori sono spariti, e con essi tutta una generazione di artigiani della brace a buonissimo mercato. Rimane il concerto bandistico in villa la mattina del 15 replicato la sera in piazza Libertà, qualche guitto in cerca di pubblico nei vicoli più vecchi, i fuochi artificiali la notte del 15, il concerto del cantante di fama la sera del 16. Quattro giorni di festa antica, nulla di più. Nulla di più semplice e puro della tradizione libera da esose pretese di eccellenza gastronomica e di bicchieri pieni di false stelle cadenti.
Feriae Augusti: Giorni di riposo di Augusto (da cui Agosto) Già nell’antica Roma i giorni di metà agosto erano giorni di vacanza, di riposo, di meritato deboscio. E sì che i romani antichi sapevano debosciarsi alla grande…Che poi il termine “feriale”, che ha la stessa derivazione latina, significa giorno lavorativo dipende dal calendario liturgico, secondo il quale ogni giorno della settimana è “feria”, salvo il sabato e la domenica. Le ferie antiche sono diventate festività con l’affermarsi del cristianesimo, che ne ha inserite molte nel calendario liturgico, spesso cambiandone il nome e legandole all’occorrenza di avvenimenti religiosi. La tradizione popolare ha fatto propria la festa e l’ha fatta diventare un momento alto di aggregazione sociale e comunitaria, accompagnando al rito religioso spettacoli laici e di divertimento collettivo. E’ il caso del ferragosto avellinese, “ferrausto” in avellinese antico ma non ancora in disuso, in cui la festività è dedicata alla madonna Assunta. Già una ventina di giorni prima del 15 agosto, il 26 luglio giorno di Sant’Anna, viene esposto al loggiato del vescovado cittadino il “pannetto”, un antico drappo celeste con l’immagine della madonna. Nel pomeriggio del 15 si svolge la processione per le strade della città, rito religioso e laico insieme, in cui una statua della madonna Assunta viene trasportata, una volta a spalla ma oggi su una macchina scoperta, tra due ali di fedeli, con a capo il vescovo, seguito in ordine rigorosamente gerarchico dalle autorità civili e religiose e da una grande folla variopinta e ciangottante, fatta non solo di avellinesi di città ma anche di molti abitanti della provincia irpina. Fino a una ventina di anni fa (o forse più), ogni avellinese emigrato, in Italia e anche all’estero, si faceva un punto d’onore la partecipazione alla processione dell’Assunta, organizzando le proprie ferie per essere presente in città nei giorni della festa. Oggi i figli ormai adulti di queste persone appartengono alle città e ai luoghi dove sono cresciuti e dove vivono, e preferiscono vacanze altre rispetto al ferragosto avellinese. Anche i giovani e giovani adulti avellinesi attuali cominciano a snobbare la festa e i suoi riti, attirati dal turismo di massa e dalla smania del ferragosto più trendy a mare, all’estero o in qualche sarabanda alcolica travestita da fiera. Questi ragazzi magari alimenteranno il pil, ma pure l’aridità sociale di una generazione che sta lavorando forse inconsapevolmente per essere sempre più settaria e individualista. Spiace dirlo, ma la recente sinistra cittadina ha grandi responsabilità nello “snobbamento” della festa più popolare, ha grandi colpe nell’abbandono delle masse lavoratrici (come si diceva giustamente una volta) nei suoi momenti collettivi più sentiti. Non è semplice folklore del Sud, come qualcuno ha liquidato la festa. Il partito rivoluzionario può anche prendere le distanze dalle manifestazioni pagane del popolo adorante un simbolo della sua sottomissione, non per questo può permettersi di disprezzare quel popolo. In fin dei conti si tratta di quel popolo che giustifica e legittima l’esistenza di un movimento di cambiamento, che legittimerebbe quindi i portatori di cambiamento e la loro compiaciuta diversità. Oggi più che mai non abbiamo bisogno di radical-chic, ma solo di radical. Dentro le cose e i fatti della gente, non fuori a fare l’avanguardia senza avanguardisti. Avanguardia giovanile, peraltro, ormai standardizzata a sua volta, irreggimentata in rumori elettronici e schiava di dj set. Il ferragosto avellinese invece e a dispetto del delirio consumistico, era un avvenimento unico, di tradizione vera, e lo rimane pur con tutta la recente concorrenza di sagre, nomepaesearte e inviti alla sbronzate (e stronzate) in giro per la provincia. Il ferragosto del popolo, proprio nella sua accezione più autentica e proletaria. Un popolo che riesce ancora a essere tale al seguito della sua madonna, madre di Gesù ma soprattutto madre consolatoria del suo stuolo di disgraziati che non a caso la invocano spesso e irrispettosamente tutti i giorni. A ferragosto si va alla processione e tutti i peccati di parola del popolo cafone si mondano di giustizia popolare e di condiscendenza religiosa. La religione è l’oppio dei popoli ma, senza alternative valide, anche la sua ancora di salvezza. La madonna Assunta e i suoi sacerdoti assolvevano (e assolvono) un’intera provincia dalle maledizioni dovute a secoli di miseria e di sfruttamento. E in più davano speranza, a un popolo che nonostante tutto aveva deciso di difendere i valori democratici e che mandava i figli a scuola. Lontani comunque i tempi in cui pullman di linea scaricavano dai paesi limitrofi decine di migliaia di persone, che casomai venivano in città solo quella volta in tutto l’anno, “po’ ferrausto”, obbligando autisti sudatissimi e abilissimi nel loro lavoro a fare servizio notturno e continuativo. Lungo il corso Vittorio Emanuele, la carrozzabile sconnessa e scura della città non ancora lastricata di bianco, si teneva la chiassosa fiera delle bancarelle, dove si poteva acquistare di tutto, dal formaggio di pecora alla catenina d’oro a pochi carati. Oggi la fiera esiste ancora, ma motivi igienici e di presunto decoro urbano l’hanno di fatto ghettizzata in periferia, rendendola niente più che un mercato rionale. La festa civile iniziava il 13 agosto, con un circuito ciclistico dilettantistico a cui partecipavano anche ciclisti del centro e del nord Italia. Qualche corridore passato per Avellino è anche diventato professionista. Un parente di chi scrive, verso la fine dei ’70, è arrivato secondo, battuto allo sprint da tale Guido Bontempi, non ancora ciclone. A causa di sempiterni lavori stradali, per diversi anni la corsa di biciclette è stata accantonata, quest’anno è ripresa. Non mancavano, e non mancano anche oggi, le bancarelle di torrone (quello irpino è fra i migliori d’Italia) e di altre leccornie come “le castagne del prete”. La città, ancora quando chi scrive era un ragazzino, si impregnava di odori di frittura provenienti dai chioschi e dai loro panini untissimi, di castagne e nocciole abbrustolite, mentre la gente cercava riposo e refrigerio sulle sedie davanti ai bar del centro, straordinariamente affollati ma col listino prezzi ordinario. Noi ragazzi andavamo alle giostre in cerca di sguardi nuovi e di avventure coraggiose. Ci vorrebbe la penna di un Raffaele Viviani, e non quella del modesto scriba, per descrivere le resse, i suoni, gli odori, i rumori e i chilometri a piedi del ferragosto avellinese (d’altronde fra le opere di Viviani c’è “La festa di Montevergine”, altra festività irpina molto conosciuta a Napoli). Oggi chi viene da fuori viene per forza in macchina, pochi azzardano un dolce da bancarella a quelli da supermercato. Molti odori sono spariti, e con essi tutta una generazione di artigiani della brace a buonissimo mercato. Rimane il concerto bandistico in villa la mattina del 15 replicato la sera in piazza Libertà, qualche guitto in cerca di pubblico nei vicoli più vecchi, i fuochi artificiali la notte del 15, il concerto del cantante di fama la sera del 16. Quattro giorni di festa antica, nulla di più. Nulla di più semplice e puro della tradizione libera da esose pretese di eccellenza gastronomica e di bicchieri pieni di false stelle cadenti.