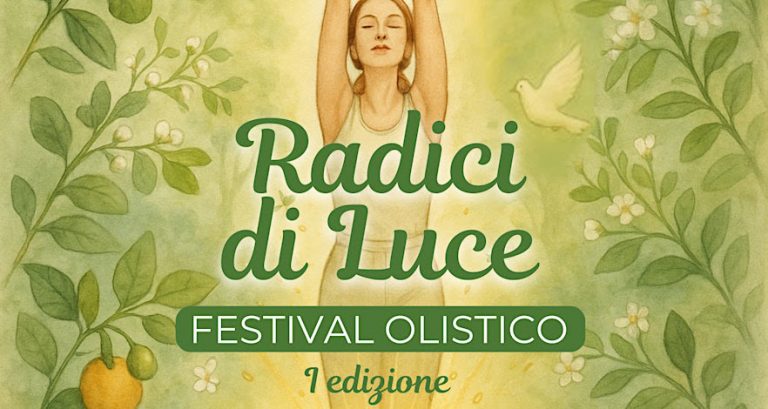Questo mese di maggio che sta passando ha celebrato, mescolando tristezza e orgoglio, due eroi reali dei nostri tempi, due eroi italiani, per giunta (molto) meridionali, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Due giudici, due vittime della criminalità mafiosa, e pure di quella parodia di stato che all’epoca, nel 1992, non seppe non solo proteggerli ma neanche sostenerli. “FalconeeBorsellino”, da quella cupa estate del 1992, è una parola sola, un concentrato di dramma e di orgoglio che ogni cittadino italiano fornito di un minimo di amor di patria non può (e non deve) non mettere nel proprio immaginario privato, a rendere più autentico quello collettivo. Pochi italiani che in quell’estate erano almeno in età da scuola elementare non ricordano dove fossero e cosa stessero facendo quando giunsero, confuse e concitate, le prime notizie, il 23 maggio e il 19 luglio. Chi scrive, che a quel tempo era un adolescente, ricorda sopratutto il volto smarrito del nonno, un volto perfino impaurito, forse rassegnato all’idea che quel Paese per il quale lui e suo padre avevano fatto le guerre mondiali era sul punto di cedere, se non già ceduto e arreso. Stragi mafiose passate alla storia come “Capaci” e “via D’Amelio”, nomi di luoghi minimi a indicare un fatto enorme: l’attacco plateale della mafia allo Stato Italiano. Uno stato impotente, in parte colluso, in parte incazzato. Uno Stato che, solo dopo quell’enormità, decise di togliersi di dosso quell’insopportabile patina di acquiescenza alla mafia e di reagire, non sempre efficacemente, ma reagire.
Il 23 maggio del 1992 quasi mille chilogrammi di tritolo furono fatti scoppiare sull’autostrada di Palermo, all’altezza di Capaci. Fu come una cannonata di grosso calibro, e uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Neanche due mesi dopo, Paolo Borsellino, collega e amico di Falcone, venne ucciso a Palermo davanti alla casa della madre, e con lui morirono ben cinque agenti della scorta: Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano e Claudio Traina.
Una bella fotografia li ritrae insieme e sorridenti, Falcone e Borsellino, mentre parlano fra loro, nonostante già sapessero che la mafia aveva deciso quello che aveva deciso. La storia sancisce e la memoria collettiva ricorda la dirittura morale di due uomini speciali, due persone normali e uniche al tempo stesso.
Prima di Falcone e Borsellino altri giudici, molti poliziotti e carabinieri erano stai uccisi dalla mano di “cosa nostra”, e alcuni già erano diventati simboli di coraggio e di senso dello Stato. In un’intervista famosa e rabbrividente Giorgio Bocca aveva scritto della solitudine a cui era stato abbandonato dalle autorità il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, quello dei “Cento giorni a Palermo”. Il generale morì ammazzato il 3 settembre del 1982, a meno di un mese dall’intervista rilasciata a Bocca, tentando invano di proteggere la moglie dalle raffiche di mitra sparate da due sicari in motocicletta. Ma nessuno come “FalconeeBorsellino” è totem dell’antimafia, e già durante i funerali (di Stato…) l’allora capo della Polizia, Vincenzo Parisi, nella calca si buscò fischi e addirittura qualche calcione dai suoi stessi sottoposti, nonostante fosse un poliziotto integerrimo.
Sulla storia mafiosa di quegli anni molto si è detto e scritto e molto, effettivamente, oggi si sa. C’è ancora un grande mistero però, quello dell’agenda rossa di Borsellino. Il giudice portava sempre con sé un’agenda rossa di colore, e anche il giorno della morte quell’agenda era nella sua borsa. Non è mai stata ritrovata. Fu presa e inguattata da agenti dei servizi segreti (italiani? Americani? Italiani e americani insieme?) precipitatisi sul luogo dell’attentato. In quell’agenda poteva esserci scritto tanto o poco, non è questo che conta; ciò che conta è che Borsellino era, evidentemente, temuto dallo “stato” ancor più e ancora prima che dalla mafia, al punto da far sparire la sua principale memoria di lavoro. Del resto lo stesso Falcone incontrava molti ostacoli nel suo ambiente, quasi come se altri giudici invidiassero i suoi successi, “esportati” anche negli Stati Uniti dove i suoi metodi di indagine contro la criminalità mafiosa diventavano modelli da studiare e da applicare. Invece in Italia quando ci fu da nominare il consigliere istruttore della Procura di Palermo dopo le dimissioni di Antonino Caponnetto, ruolo che a Falcone spettava di diritto titolo, il Consiglio Superiore della Magistratura gli preferì Antonino Meli, un magistrato con una maggiore anzianità di servizio…Falcone venne spedito a Roma, al ministero della Giustizia presieduto dal socialista Claudio Martelli: così il pesce fu tolto dalla sua acqua.
Due anni prima dell’attentato di Capaci, durante un breve vacanza di Falcone in una villa sull’Addaura la scorta trovò sugli scogli vicini alla villa alcuni candelotti di dinamite; si arrivò a dire che erano stati messi da Falcone medesimo per aumentarsi la fama e per costringere lo Stato a meglio tutelarlo. Erano già i tempi in cui alcuni giornali sguazzavano nel fango lanciato contro i cosiddetti “professionisti dell’antimafia”, la polemica contro Borsellino e il pool antimafia di Palermo (Chinnici, Caponnetto, Falcone, Borsellino, Natoli, Di Lello e Guarnotta, la cui attività portò all’arresto di più di 400 mafiosi e alla celebrazione del maxiprocesso) scatenata, inaspettatamente, dallo scrittore Leonardo Sciascia, proprio quello che tanto aveva scritto e pure di memorabile contro la mafia e i suoi sordidi intrecci con la politica.
Sia come sia, forse sull’onda lunga di tangentopoli e comunque non potendo continuare a soccombere dopo aver subito l’affronto dell’uccisione di Falcone e Borsellino, lo Stato riprese la spugna “deandreanamente” gettata con gran dignità e finalmente passò alla controffensiva…Abituati agli sceneggiati televisivi, ai film in cui i mafiosi vivono in case lussuose, gli italiani si sconcertarono quando videro, nei giorni successivi all’arresto, dove e come vivevano i capi della “cupola” studiata e già incalzata da Falcone. Totò Riina e Bernardo Provenzano, i due boss corleonesi, vivevano dentro abituri di campagna, in stato semibrado; due semianalfabeti che dirigevano e gestivano quell’organizzazione criminale così ramificata e spietata, poteva mai essere possibile? La risposta, anche a leggere alcuni atti del giudice Falcone, è affermativa, e tanta ferocia era in qualche modo connaturata all’origine sociale e geografica dei capi.
Oggi, non dimenticando la “trattativa stato-mafia” il cui complesso processo è ancora in corso, altresì non escludendo l’effettiva autenticità del papello (il foglio di carta in cui cui la mafia faceva l’elenco delle sue richieste allo Stato in cambio della “pace”), la fase delle stragi di mafia può dirsi finita. Non è stata sconfitta del tutto, ancora latitano mafiosi potenti come Messina Denaro, ma la potenza politica della mafia e soprattutto il suo radicamento sociale possono considerarsi quasi del tutto debellati. Tutto quello che è stato fatto contro la mafia negli ultimi anni, è stato fatto seguendo l’esempio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “FalconeeBorsellino”, uniti per sempre, uniscono persino gli italiani.