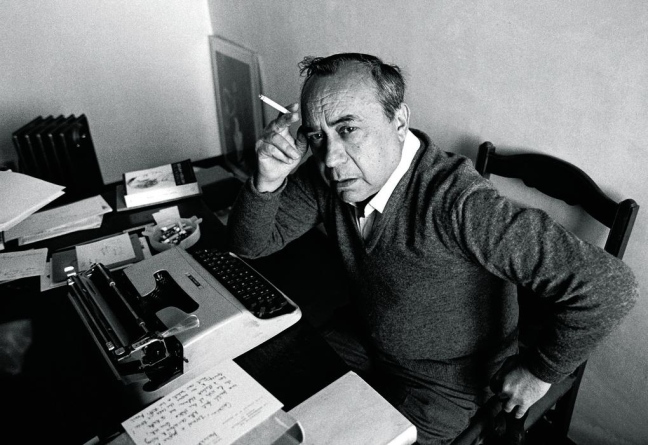
Un uomo tanto semplice nel privato quanto complesso come narratore, dispensatore dei dibattiti più accesi e proficui, capace di far danzare in sincrono le molteplici sfaccettature della sua persona, al fine di soverchiare l’ipocrisia del reale “Anche a costo di fraintenderlo“, in grado di provocare reazioni polemiche in relazione ai suoi ideali politici e di giustizia. Leonardo Sciascia, figura emblematica del secondo Novecento italiano, la cui mancanza risuona come un eco nelle lunghe notti di un inverno mesto ed impoverito a cent’anni dalla sua nascita, e che venerdì otto gennaio celebrerà trentuno anni dalla sua morte.
Classe 1921, conseguì il diploma magistrale nel ’41 e lavorò presso il Consorzio Agrario a Racalmuto, in provincia di Agrigento, entrando a contatto con il mondo agreste fino al 1949, quando diviene maestro elementare.
In qualità di narratore esordì con libri legati alle sue amate e mai rinnegate radici sicule, stilando le “Parrocchie di Regalpetra” (piccolo borgo arroccato dietro la sua natale Racalmuto, in cui fece ritorno fino alla fine dei suoi giorni) e “Gli zii di Sicilia“, da cui già si evinceva il tratto dominante della sua formazione illuminista, o per meglio dire volterriana (proprio sulla base del “Candide“ egli scrisse, nel 1977 “Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia“). Si tratta di una serie di rivisitazioni storiche lette nell’ottica di proletari siciliani.
E’ da lì che emerse il suo desiderio oltremodo metaforico di raccontare e spiegare i segreti e i meccanismi di potere nella sua terra, a partire da quello mafioso che tutto travia (basti pensare a “Il giorno della civetta” e “A ciascuno il suo” nei primi anni 60) e, successivamente, dipanando la sua volenterosa e paziente esplorazione nell’Italia democristiana e socialista in genere: si ricordano ‘Il contesto‘, ‘Todo modo‘ per terminare con ‘L’affaire Moro’ negli anni ’70, con risultati a volte pungenti.
Come scrittore debuttò invece nel 1950 con un volume di poesie, ‘Favole della dittatura’ (recensito da Pasolini), e poi con ‘Gli zii di Sicilia‘ (su una copia del quale si racconta che il padrino gli chiese la dedica dopo un’intervista e l’autore scrisse: “Allo zio di Sicilia, questo libro contro tutti gli zii”); in seguito ai saggi ‘Morte dell’inquisitore‘ e ‘Feste religiose in Sicilia’, nel 1969 iniziò a scrivere per il Corriere della Sera. Fu poi la volta di due racconti a tinte gialle, ‘La scomparsa di Majorana‘ e ‘Il teatro della memoria’, prima del suo impegno attivo in politica che lo vide eletto consigliere comunale a Palermo nel 1975, con dimissioni dopo due anni, per accettare nel 1969 la candidatura nelle liste radicali in Europa e alla Camera dei Deputati, per la quale optò dopo due mesi a Strasburgo, finendo negli anni ’80 per esprimere pubblicamente le sue simpatie per il Partito Socialista Italiano e chiedendo esplicitamente a Bettino Craxi di rinnovare la classe politica siciliana, guadagnandosi ironie e contraccolpi. Rivendicò spesso l’affermazione “Né con lo Stato né con le Brigate Rosse“, e denunciò alla Camera la possibilità di torture nella lotta al terrorismo.
Uomo agitato, smanioso, alla perenne ricerca di qualcosa che gli sembrasse più adatto a soddisfare il proprio bisogno di non appartenenza ed essere controcorrente, arrivò a scrivere nel 1987 un celebre articolo ‘Contro i professionisti dell’antimafia‘, che gli valse isolamento e critiche amare da tutto il mondo della cultura e della politica di sinistra, fino a decidere amaramente di abbandonare il Corriere e collaborare con La Stampa. I suoi romanzi trovarono la propria forma in un’abile chiave di volta gialla, come genere coinvolgente che nasceva dalla sua ricerca illuminista della verità, ma rettificata (egli vinse il Premio Pirandello nel 1953 e redasse ‘La corda pazza’, titolo che rimanda alla teoria espressa nel ‘Berretto a sonagli’) da un’indispensabile vena pirandelliana, grazie all’ironia di fondo legata a quella impossibilità obiettiva di distinguere tra verità e menzogna. Per alcuni versi quindi i gialli di Sciascia sono anticipatori del filone di noir mediterraneo, che adotterà il genere per farne denuncia civile, sociale e di costume. In questa prospettiva, complementare tema di Sciascia è certamente l’importanza del ricordare, della Μνημοσύνη, avrebbero detto i greci.
Sorprendentemente, il mistero non appariva a Sciascia nel primo momento del suo rapporto con il mondo circostante. Tutto all’inizio era invece chiaro, razionale e sicuro. Poi, però, via via che il letterato procedeva nella sua implacabile analisi, il rapporto con la verità diventava sempre più oscuro, dubbioso, enigmatico e finalmente, al posto della certezza originaria, subentrava appunto l’oscurità del mistero.
Sciascia procedeva dunque con il metodo opposto a quello dei suoi amati illuministi: questi andavano dal mistero alla verità e alla razionalità; Sciascia andava invece dalla verità e dalla razionalità al mistero. Sciascia era un illuminista per così dire paradossale anche se il suo illuminismo consisteva nel bilanciare la “sicilianità” con l’influenza di scrittori come Voltaire e Manzoni, forse più il secondo che aveva un vivo senso del mistero che il primo.
Si potrebbe vedere in questo capovolgimento del metodo illuminista un segno del pessimismo siciliano, quel pessimismo fatto di strenua volontà di razionalità e chiarificazione, seguito però immancabilmente da una regolare e inevitabile caduta nella confusione e nell’incertezza.
Sciascia era un tipo di scrittore di piglio classico, cioè non decadente, né prezioso, né formale, ma, sia pure attraverso una scrittura essenzialmente letteraria, era legato quasi suo malgrado al reale.






