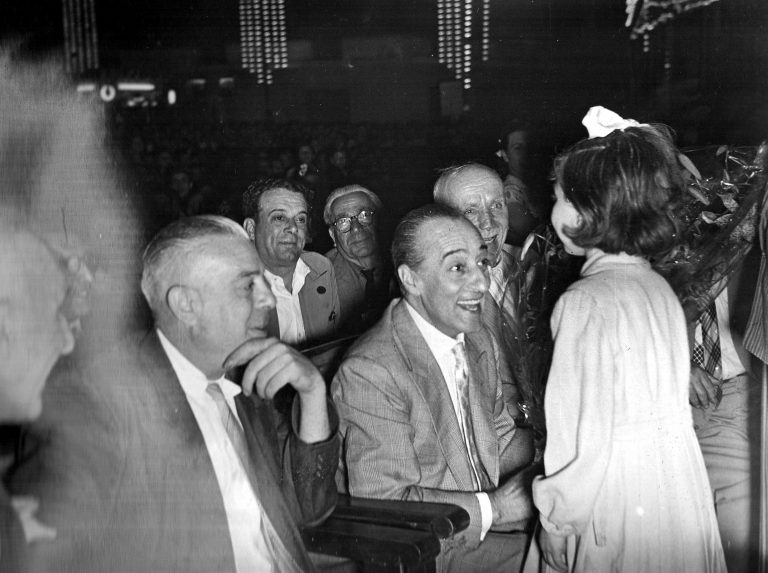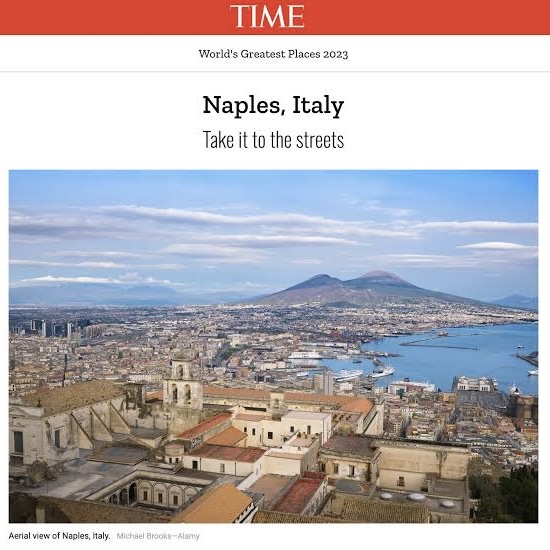Trascorso qualche giorno dalla festa della Liberazione e dalle relative polemiche sempre più avvilenti, capziose e tendenzialmente perniciose, vogliamo tentare anche noi una riflessione, possibilmente assennata, sull’argomento.
Il 25 aprile (Liberazione) e il 2 giugno (Festa della Repubblica) sono le ricorrenze civili più importanti dello Stato italiano. In particolare il 25 aprile ricorda la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, grazie a una lotta di resistenza ufficialmente iniziata subito dopo l’8 settembre 1943 e durata un anno e mezzo. Proprio il 25 aprile del 1945 i partigiani vittoriosi sfilarono per le strade di Milano, guidati da Luigi Longo e Ferruccio Parri, quest’ultimo comandante del Comitato di Liberazione e in seguito anche presidente del Consiglio dei Ministri, prima della spaccatura fra i partiti del Comitato voluta soprattutto da Alcide De Gasperi e dagli anglo-americani. Ecco il motivo per cui, solitamente, la festa della Liberazione ha come epicentro e luogo simbolo la città di Milano.
Napoli, sempre bene ricordarlo, fu la prima grande città (italiana ed europea) a mettere in fuga gli occupanti tedeschi e a farlo da sola, senza aiuto dei militari alleati; la famose “quattro giornate” di Napoli, 27-28-29-30 settembre del 1943, restano orgoglio e vanto della città, prova tangibile della voglia di libertà che pervadeva la città, esasperata dalla guerra e dalle angherie dei fascisti e dei tedeschi, indisponibile ad accettare passivamente la consegna della città ai tedeschi da parte dei generali italiani di comando nella provincia di Napoli, anch’essi allo sbando dopo l’armistizio e privi di ordini superiori. Il proclama nel quale il colonnello tedesco Scholl stabiliva l’occupazione militare della città, il coprifuoco e lo stadio d’assedio, legittimando (se ancora ce ne fosse stato bisogno) rastrellamenti, rappresaglie e fucilazioni sommarie (cento napoletani per ogni tedesco ferito o ammazzato! “Ogni soldato germanico ferito o trucidato verrà rivendicato cento volte”), sortì l’effetto contrario a quello sperato dagli occupanti. Non c’era più paura nei napoletani, e se c’era non era comunque più forte dell’odio verso i tedeschi e dell’ansia di riprendersi la città e una vita libera. Mussolini aveva visto giusto quando, con parole infelici (ma anche indegne) e già nel 1935, ebbe a dire che Napoli era città impossibile da fascistizzare fino a ipotizzare una “marcia su Napoli” al fine di piegarla ai dettami e ai mottetti del regime. Mussolini non trovò mai il coraggio di fare la marcia su Napoli, ma non perse la visione razzistica sui napoletani e, come annotava il genero Galeazzo Ciano nei suoi diari, proprio durante i tremendi bombardamenti che la città subiva per colpa e causa della guerra fascista, il suocero Mussolini così commentava: “Sono lieto che Napoli abbia delle notti così severe. La razza diventerà più pura e la guerra farà dei napoletani un popolo nordico”. E qui, a melodiosa ed elegiaca risposta, ci vorrebbe solo la pernacchia di Eduardo…L’insurrezione di Napoli dimostrò a Mussolini e ai tedeschi, stroncandoli nelle loro certezze, che Napoli era fatta da un popolo consapevole e coraggioso, incompatibile con dispotismi e dittature. In quei giorni Napoli fece da esempio per il resto del Paese, come pensava anche il partigiano comunista Luigi Longo: “Dopo Napoli la parola d’ordine dell’insurrezione finale acquistò un senso e un valore e fu allora la direttiva di marcia per la parte più audace della Resistenza italiana”. Del resto e senza svaccare dalla serietà dell’argomento, a quale cristiano vivente in Campania, in una qualsiasi debosciata domenica pomeriggio, non è mai capitato di bloccarsi su Canale 9, ipnotizzato da un giovane Gian Maria Volontè grondante sudore dietro una barricata in un film in bianco e nero?…
Formazioni partigiane operarono anche in Abruzzo, Toscana e Marche, ma il grosso della resistenza si svolse al nord, soprattutto in Emilia, Piemonte, Lombardia e Veneto. Le iniziali bande partigiane divennero sempre più numerose, organizzate e guidate da comandanti leggendari come Duccio Galimberti e Germano Nicolini (il “comandante Diavolo”), attirando nei ranghi giovani e adulti desiderosi di spazzare via vent’anni di dittatura fascista. Ancora a Milano si formò il C.L.N.A.I. (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) a cui parteciparono rappresentanti dei partiti politici tanti anni prima sciolti da Mussolini. Alcune brigate partigiane addirittura costituirono repubbliche autonome, come quelle di Alba e Montefiorino, che ebbero sì vita breve ma riuscirono a diffondere le idee partigiane fra contadini e montanari. Nell’aprile del 1945 le brigate Matteotti, le brigate Garibaldi e i gruppi di Giustizia e Libertà occuparono Genova e poi Milano, che Mussolini abbandonava inguattato dentro il pastrano di un soldato tedesco…
Nessuno vuol far passare l’idea che la guerra contro i nazifascisti sia stata vinta dalla Resistenza, però, fra le varie resistenze europee al nazismo, la più forte dopo quella jugoslava (che cacciando via i tedeschi riuscì a creare un nuovo Stato) fu senz’altro quella italiana.
Un aspetto particolare ebbe la resistenza francese, capeggiata da Charles De Gaulle e che in Inghilterra fruì dell’appoggio militare britannico, al punto da costituire in seno all’esercito di sua maestà un corpo di spedizione francese che ebbe l’onore di entrare per primo nella Parigi liberata.
Ora, nella storia moderna dell’Italia due sono i periodi di sincera partecipazione popolare, il Risorgimento e la Resistenza: movimenti fatti certamente da minoranze ma altrettanto certamente decisivi per le sorti del popolo italiano. Poi si sa, molti “eroi” salgono sul carro del vincitore a cose fatte e le cifre si gonfiano.
Dopo i primi anni di esaltazione agiografica, gli storici hanno meglio analizzato il movimento della Resistenza; interessante la tesi dello storico (e partigiano) Claudio Pavone, che in seno alla Resistenza ha distinto tre movimenti fra essi intersecanti: quello della liberazione dallo straniero e dal nazifascismo, quello di progresso sociale, promosso anzitutto dalle brigate Garibaldi di ispirazione comunista, e quello sfociato nella guerra civile. Sull’analisi di Pavone molti storici, anche di diversa formazione, concordano, ponendo attenzione su singoli episodi che portano a valorizzare l’uno o l’altro movimento.
La sfilata del 25 aprile ha sempre visto, sin dal primo anno, la partecipazione delle autorità dello Stato oltre che dei partigiani. L’organizzazione è sempre stata doverosamente affidata all’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), a cui, stante la naturale dipartita di molti partigiani originali, si può iscrivere chiunque condivida i medesimi ideali di quegli uomini (e donne) che si batterono sulle montagne, nelle vallate, nei boschi e sui fiumi per una nuova Italia. La sfilata principale è stata fatta per molti anni a Milano, che ha sempre risposto bene e con ottima affluenza.
Purtroppo da più di venti anni la festa del 25 aprile viene banalizzata e ridimensionata, da quando il (milanese) presidente del Consiglio Berlusconi decise di non partecipare, forse perché nel suo delirio propagandistico anticomunista non riusciva a mandar giù il fatto che le brigate Garibaldi furono il nerbo della Resistenza. Per non parlare della proposta di Berlusconi nel 2009, nel mentre del gabinetto Silvio IV (e speriamo ultimo), di trasformare la festa della Liberazione in berlusconiana “festa della libertà” con annesso riconoscimento delle “ragioni” dei fascisti di Salò (e magari riapertura nella settimana dal 25 aprile al 1° maggio dei vecchi lupanari del “ventennio”, con le tariffe originali e le meretrici in sottane d’epoca). La proposta di Berlusconi non fu presa in considerazione da nessuno (e meno male!) e quello, che uomo fesso non è, capì che era meglio lasciar perdere certe fesserie. La cerimonia ufficiale del 25 aprile ha cambiato più volte sede, quest’anno si è svolta a Carpi alla presenza del capo dello Stato.
Pur non volendo sottovalutare l’anticomunismo berlusconico, l’insidia più grave ai valori della Resistenza è venuta comunque dalla recente pubblicistica di stampo revisionista, capeggiata dai romanzi di Giampaolo Pansa. A dirla tutta, Pansa di mestiere è giornalista, magari anche scrittore, giammai uno storico. I suoi racconti sul “triangolo della morte” (zona del modenese o, a seconda di che ne scrive, compresa fra Bologna, Reggio Emilia e Ferrara) hanno riscosso un innegabile successo di lettori, venendo più volte ripresi da epigoni minori e di chiara impostazione anticomunista quando non apertamente fascista. La buonanima di Giorgio Bocca, letto il primo libro revisionista di Pansa, ruppe definitivamente col collega, in seguito criticandolo in molti articoli e nella rubrica che teneva su “L’Espresso”, giornale a cui collaborava lo stesso Pansa.
Volendo a forza mantenere una posizione equilibrata, bisogna convenire con i “revisionisti” che in quel periodo storico certamente ci furono degli eccessi di violenza, come purtroppo succede nelle guerre civili, a cominciare dall’esposizione a Milano, in piazzale Loreto, dei cadaveri di Mussolini, di Claretta Petacci e dei gerarchi catturati e fucilati a Dongo, su cui la folla esasperata e inferocita infierì, a stento trattenuta da un improvvisato servizio d’ordine. Per quanto riguarda omicidi e vendette personali, sicuramente ce ne furono dopo la liberazione, ma già storici comunisti come Dondi e Storchi ne hanno parlato nei bollettini dell’ANPI, come pure tutto si è sempre saputo sulla strage di Porzus, dove partigiani “bianchi” furono fucilati da partigiani “rossi”. Epperò roba dei fascisti erano le camere di tortura, in cui aguzzini criminali come i membri della famigerata “banda Koch” (da Pietro Kock, il capobanda, beneventano di nascita) torturavano i prigionieri fino alla morte. Molti partigiani (e non solo partigiani) finirono morti ammazzati in quel modo esecrabile. Per non parlare delle rappresaglie fasciste contro i familiari dei partigiani e civili inermi, “colpevoli” di aver aiutato i ribelli. Sulla bilancia della storia contestualizzata, come sostengono gli studiosi seri, non si può utilizzare la stessa tara per misurare e giudicare ogni violenza, le violenze di chi lottava per la libertà e quelle di chi lottava contro la libertà.
La Costituzione della Repubblicana Italiana vieta, e diversamente non potrebbe essere, la ricostituzione del partito fascista, eppure un partito apertamente rifacentesi a quella ideologia, il “movimento sociale”, è stato liberamente presente in Parlamento per quasi cinquant’anni; il suo ultimo segretario Gianfranco Fini, prima della sua personale conversione liberale, arrivò a definire Mussolini il più grande statista del ‘900. Va da sé che il movimento sociale, cioè la destra italiana nella cosiddetta “prima repubblica”, mai ha rinnegato o seriamente criticato il fascismo. Tutt’altro atteggiamento ha avuto invece la destra francese. Ricordiamo che nella Francia occupata dai nazisti, in più della metà della nazione comandò per quattro anni il governo collaborazionista del maresciallo Petain, il cosiddetto governo di Vichy; ebbene, dopo la liberazione, molti fascisti italiani e collaborazionisti francesi furono giudicati da appositi tribunali, e i condannati a morte francesi superarono di gran lunga quelli italiani. Di più nel 1946, a guerra finita, Palmiro Togliatti ministro di grazia e giustizia, magari pure costretto dal governo provvisorio di cui faceva parte, comunque decretò l’amnistia anche per i condannati politici fascisti. La destra francese ha governato il Paese per molti anni, mai rimpiangendo Vichy e mai venendo meno alla forma di destra repubblicana e sempre allontanando da sé qualsiasi ideaccia di autoritarismo. Durante la rivoluzione francese circa 23.000 aristocratici vennero scapati, eppure i loro discendenti partecipano con orgoglio (altresì con la mano destra sul collo…) alla festa nazionale del 14 luglio. Questo per dire che un Paese, per essere davvero tale, deve riconoscersi collettivamente e unitariamente in qualcosa, di solito un evento di rivoluzione o di liberazione o entrambe le cose insieme. In Italia questo fatto collettivo potrebbe e dovrebbe essere la liberazione dal nazifascismo e quindi il 25 aprile, invece, pur di non cedere ai “comunisti”, la destra italiana (e non solo la destra) continua a fare la destra reazionaria. Il movimento sociale si è sempre rifiutato di riconoscere il 25 aprile e vabbe’, erano fascisti dichiarati e dichiaratamente stavano nelle istituzioni democratiche senza apprezzarne il valore. Ma oggi, nel 2017, che quasi nessun partito presente in Parlamento renda realmente omaggio al 25 aprile appare ridicolo almeno quanto intollerabile. I leghisti veneziani squinternati e nostalgici della Serenissima possono nascondersi le vergogne sotto la coda del leone di san Marco, la cui ricorrenza cade proprio il 25 aprile, ma gli altri partiti e partitini dove cavolo possono nascondersi? E soprattutto come si permettono di nascondersi?! Dove cavolo sono i liberi partiti politici (articolo 49 della Costituzione) nel giorno in cui si celebra la libertà politica della nazione?…
E venendo al PD o a quello che ne rimane, il partito che comunque dovrebbe essere il principale erede politico dei valori della Resistenza per il secondo anno consecutivo ha rifiutato di partecipare alle celebrazioni ufficiali. “La democrazia è qui”, scrive tale PD Nazionale in sms fastidiosi e misteriosi (in quanto privi di recapito telefonico a cui eventualmente e garbatamente rispondere…) di pubblicità alle imminenti “primarie”. Ma qui dove? E soprattutto come? Quale democrazia ci sarebbe stata in Italia senza la lotta di Liberazione? Di quale democrazia parlerebbe il PD senza il “25 aprile” dal PD non celebrato?…Quest’anno la scusa trovata è stata la polemica rinfocolata dalla “brigata ebraica” contro la presenza nel corteo romano delle bandiere della Palestina e delle associazioni filo-palestinesi, altra questione piuttosto strumentale e variamente commentabile. Dal punto di vista storico non si può non tener conto che durante la seconda guerra mondiale il gran mufti di Gerusalemme strinse con Hitler un patto antiebraico. Dal punto di vista geopolitico non si può non tener conto che gli israeliani da cinquant’anni occupano militarmente i territori palestinesi. Dal punto di vista “filosofico” non si può non tener conto che il PD non fa più neanche finta di essere un partito di sinistra.
Nonostante questi problemi, e nonostante il PD, non si può né si deve cadere nel trappolone di chi, a più di settant’anni dalla fine della guerra, utilizza ancora la Resistenza e la festa della Liberazione come motivi di polemica inutile tra attuali fazioni (più o meno) politiche, e così facendo il gioco di quelli che vogliono ghettizzare il 25 aprile a festa di parte oltre che partigiana. Che piaccia o meno a quelli a cui non piace la libertà (o che più semplicemente non ne afferrano le origini), il 25 aprile è anche la loro festa.
Senza nutrire alcuna pretesa pedagogica, la citazione di cinque facilmente fruibili opere sulla Resistenza, che hanno molto colpito chi scrive, preme doverosa.
Il partigiano Johnny – Una questione privata, romanzo del 1968 di Beppe Fenoglio
Lapide ad ignominia, poesia del 1952 di Piero Calamandrei
Paisà, film del 1946 di Roberto Rossellini
La notte di San Lorenzo, film del 1982 dei fratelli Taviani
Le quattro giornate di Napoli, film del 1962 di Nanni Loy, la domenica pomeriggio su Canale 9…