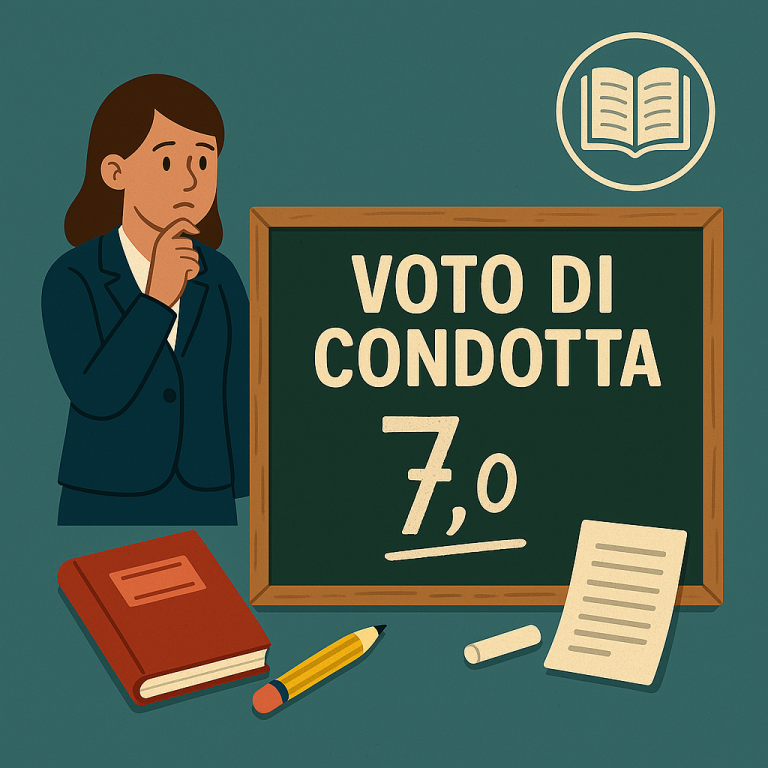Tante volte, discutendo con alcuni sensibili colleghi, ho ripensato all’importanza della scuola. Il parlare tra noi è simile ad uno scongiuro, un’invocazione: “perché?”, tanti “perché?”: come fare, come coinvolgere questo o quel ragazzo, come destare delle intelligenze dormienti.
Spesso mi capita di lasciare il percorso ‘ministeriale’, sollecitata da domande che emergono improvvise e inattese dalla bocca e da cervelli sotto l’incantesimo dei ‘grandi fratelli’. Compiaciuta seguo il percorso delle domande – tanto so poi come ‘recuperare’ la lezione su Kierkegaard o Ortega y Gasset – ed insieme con loro prendo ad analizzare la questione posta.
La guerra che ci circonda, i complotti veri o presunti, i misteri italiani, le ansie personali. Mi rendo conto che troppe cose ignora questa ultima generazione, troppo sola e abbandonata. Sì perché queste questioni erano, fino a non tanti anni fa, argomento di scambio e confronto in famiglia. Allora domando: “Ma, una volta a casa, parlate di quanto avete fatto a scuola?”. La risposta è di una tristezza inesprimibile, è un “no” dovuto a superficialità e distrazione del mondo degli adulti.
Sono soli questi ragazzi. Forse l’espressione più inquietante dell’individualismo del nostro tempo, un individualismo che parte da lontano: dai loro genitori dai loro nonni, dalle delusioni sulle scelte politiche di questi ultimi venti, trent’anni. Ma il loro non è individualismo: è solitudine, dolorosa e profonda, al punto di non avvertirla per quella che è. Solitudine, frutto avvelenato dell’individualismo.
È allora che apprezzo ancor più la scuola e l’opportunità che mi ha dato e che mi dà. Questa solitudine diventa per i più deboli, i più sensibili, una voragine, come mi attestano le vite di alcune studentesse, ora fuori dai banchi di scuola, che continuo a seguire e sentire. Nessun lavoro può darti quello che la scuola ti dà in relazioni umane e impegno. Qui, tra questi banchi c’è la storia, quella vera, quella dell’uomo che è da sempre alle prese con i suoi problemi; c’è il naturale desiderio di relazione e condivisione, di felicità: luogo dell’anima in cui la cultura non è arido nozionismo.
La agogno da sempre una “buona scuola”, che non è certo quanto i governanti ci hanno propinato, meno che mai è l’azienda senz’anima di questi ultimi anni, culminati con una presuntuosa riforma che non riforma nulla e lascia tutto come sta.
La buona scuola è una palestra di vita, richiede capacità di ascolto e di accoglienza, cultura e desiderio mai spento di apprendere; passione: cuore e mente che pulsano, perché ogni inizio d’anno, ogni singola ora è l’inizio di una nuova avventura, priva di schematismi, perché l’uomo non è mai ripetitivo nella sua evoluzione, ma sempre nuovo; è entusiasmo, che diventa coinvolgente nei momenti decisivi, come l’esame di maturità: esperienza impagabile che vede i docenti e i discenti, come mai prima, coinvolti in un percorso ad ostacoli che insieme devono superare.
Insieme: la buona scuola si fa insieme, si spiega e si risponde alle sollecitazioni, si invitano gli studenti alla collaborazione, si studia insieme, si ride insieme, perché i docenti sono lì per permettere a quanto c’è di meglio in ogni giovane, di venir fuori in un ben organizzato sistema di pensiero; si cresce insieme. È cultura, perché la cultura è vita.
Esperienza di libertà, liberata e liberante: liberi da sé, liberi per gli altri. Con tempi e orari diversificati, con ore in cui poter incontrare i propri studenti per un approfondimento o un aiuto; con strutture atte a realizzare giornate articolate con orari meno noiosi di quelli di oggi.
Fondamentalmente, la buona scuola non è e non può esser concepita come un’azienda, il solo pensiero mi risulta raccapricciante e stomachevole. Noi abbiamo a che fare con l’uomo, con le sue molteplici sfaccettature, con la sua bellezza e con i suoi dubbi, con quell’abisso inesplorabile che è, appunto, l’Uomo.
Non produciamo bulloni né automobili, né altro. La nostra non è una produzione, perché l’uomo non è mai un prodotto per il mercato!
“Che dici, Rosa, di Umberto B.? Cosa possiamo fare?”; “Cosa è meglio per lui?”. Quando parliamo così, non parliamo di un modello d’auto mal riuscito. Parliamo con quella professionalità, in cui rientra quell’empatia che è fondamentale per un docente, che ci spinge ad interrogarci, alla fine di un anno di lavoro, sul destino di un giovane alunno a noi affidato.
Poveretta la Giannini e poveretti gli altri! Non capiranno mai o, forse, non vogliono capire. Capire vuol dire essere tutto ciò che non sono: uomini di cultura impegnati per il bene comune.
Poveretti anche noi? Non credo! Perché noi sappiamo qual è la nostra identità e il senso del nostro lavoro. Sottopagati, maltrattati, omologati, colpevolmente, alla Pubblica Amministrazione incredibilmente resistiamo agli attacchi. Certo, anche il fronte più solido può essere sfondato. Fino ad ora, ancora non sono riusciti. Confido che non ci riusciranno mai.
Questa la testimonianza di una docente, la prof.ssa Rosa Morelli