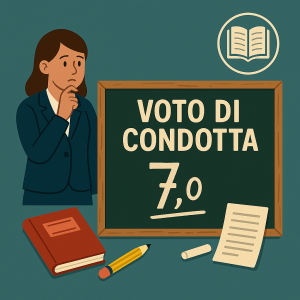“Lunga vita al compagno Pietro!” urlò con voce possente un militante torinese con fazzoletto rosso al collo dalla grande piazza sotto il palco degli oratori. Era la campagna elettorale per le elezioni politiche del 1963 e quel militante comunista non poteva immaginare che il suo augurio sarebbe diventato una profezia.
Il 30 marzo del 1915 nasceva in Terra di Lavoro Pietro Ingrao. Cent’anni fa nasceva il compagno Pietro, quando presidente del Consiglio era il dauno troiano Antonio Salandra, della Destra storica, e quando l’unico modo di comunicare a distanza era la lettera di carta, col “telegrafo parlante” (il telefono) nella disponibilità solo di banchieri, capistazione di grandi stazioni, marconisti in traversata e soldati radiofonisti in guerra. Cent’anni dopo presidente del Consiglio è il fiorentino Matteo Renzi, della Destra economica, si comunica via “feisbuk” e il compagno Pietro, per rimanere al passo coi tempi, ha un suo profilo sul social. Ha pure un www personale, il compagno Pietro, in cui d’impatto si legge il suo amore per la rivolta ad augurare al visitatore la buona esplorazione del sito. Amore per la rivolta e per il comunismo che lo porta ad essere, pure a cento anni, icona della Sinistra assente di questi tempi e ideologo della sua introvabile unità.
Colto, bello, simpatico, radicale, critico verso il partito ma sempre dentro il partito, rivoluzionario non senza popolo, Pietro Ingrao se non cento rappresenta almeno ottanta anni di progressismo in Italia. A partire dalla guerra civile di Spagna quando, 1936, il giovane Pietro, già laureato in Legge e allievo regista al Centro sperimentale cinematografia di Roma, di fronte all’aggressione franchista della repubblica spagnola decide di stare dalla parte degli antifascisti, non tanto in Spagna quanto in Italia. Fino all’anno prima era un giovane fascista, fra i più promettenti intellettuali del regime e pure poeta cantore della bonifica dell’agro-pontino. Eppure i familiari di Pietro, proprietari terrieri illuminati, sono di solida tradizione liberale, col nonno Francesco Ingrao camicia rossa garibaldina, mazziniano e fervente repubblicano (“La sola carabina è il mezzo per passare dalle istituzioni monarchiche alla Repubblica” scrive in una sua lettera). Epperò le idee camminano con le gambe degli uomini secondo un altro Pietro (Nenni), così Pietro (Ingrao) trova la sua idea da portare a spasso attraverso il Novecento nel marxismo e nella lotta di classe. Nei giorni caldi di quel luglio del 1936 è Antonio Amendola, futuro dirigente del PCI, a convincere Pietro della necessità di abbandonare definitivamente il fascismo e le sua presunte avanguardie per passare alla lotta comunista. Sono tempi incerti in Italia, tempi apparentemente pieni solo di saluti romani e di mottetti idioti, tempi invece pieni di anche di altro, di idee libertarie e socialiste, di letteratura russa e americana, di cinema di celluloide, di opposti che forzosamente si attraggono, di repubblichini di Salò tali solo “per non perdersi la sconfitta”, tempi brutti per i pacifisti e per i liberali ma belli per chi voglia inseguire un sogno politico estremo. Non pochi giovani virgulti fascisti degli anni ‘30 e ‘40 saranno dirigenti socialisti e comunisti nel Dopoguerra…Pietro Ingrao invece non fa l’amore a lungo col fascismo, lo abbandona all’età della ragione. Non parte per la Spagna, non segue il compagno Giuseppe Di Vittorio e tanti altri a combattere contro le truppe della reazione, ma cerca di organizzare il partito comunista in Italia e scrivere il suo foglio fuorilegge, l’Unità. Fino all’inizio della guerra nazista Mussolini in fin dei conti lascia fare ai giovani bolscevichi italiani i loro giornali, clandestini ma trovabilissimi nei centri più grandi. Coll’inizio della guerra la repressione fascista si fa più costante, metodica, e molti del gruppo di Ingrao vengono arrestati. Pietro allora cerca di operare fra Milano e la Calabria, ma la situazione è quella che è e non si può fare più di tanto. Nascosto oltre che militante, ma già preparato a sfruttare il primo serio cedimento del regime. Cedimento che si materializza il 25 luglio 1943 col voto del gran consiglio del fascismo favorevole all’arresto di Mussolini. Il giorno seguente Pietro insieme a Salvatore Di Benedetto, Elio Vittorini e Celeste Negarville organizza il famoso comizio di Porta Venezia a Milano, primo pubblico comizio, in Italia, contro il fascismo a fascismo ancora al governo. Nella casa del pittore Ernesto Treccani quei compagni preparano uno storico numero dell’Unità finalmente non clandestino (ma lo sarà – non clandestino – solo per quel numero, almeno fino al 2 gennaio 1945) intitolato “L’arresto di Mussolini. Italiani gridate nelle piazze pace e libertà!”.
È l’inizio della grande riscossa per Pietro e i suoi compagni dell’Unità, che ormai è il giornale ufficiale della Resistenza, portato di nascosto ai partigiani sui monti da donne e da altre staffette insospettabili, Gino Bartali fra gli altri, il mitico Ginettaccio. La liberazione dal nazifascismo trova il compagno Pietro preparatissimo alla costruzione della nuova Italia democratica e repubblicana. È il periodo in cui, come dirà Pietro molti anni dopo, l’impegno politico è combattuto fra tensione democratica e tensione rivoluzionaria, fra attività parlamentare e attesa “del momento in cui ci saremmo trovati – l’uno di fronte all’altro – noi rivoluzionari e le truppe del grande capitale”. Nel 1947 il partito gli affida la direzione dell’Unità, e per dieci anni Pietro svolge il suo compito con passione e fantasia; sono gli anni migliori per il giornale fondato da Antonio Gramsci, gli anni in cui la storia d’Italia racconta la nascita della Repubblica, la sconfitta comunista e socialista alle elezioni del 1948 e la vittoria democristiana, l’inizio dell’egemonia bianca nel governo e di quella rossa nella cultura. E per la storia della Sinistra succedono fatti fondamentali: la morte di Stalin, il XX congresso del PCUS e la denuncia dei crimini di Stalin, la destalinizzazione dell’URSS e la smitizzazione di Stalin nei Paesi occidentali, l’attentato a Togliatti per mano dell’irpino di nascita Antonio Pallante (tuttora vivente), l’invasione dell’Ungheria del ’56. Pietro per dieci anni dirige il quotidiano contro la volontà dei vecchi compagni del comitato centrale, che mal sopportano quel “Corriere della Sera della classe operaia” che Palmiro Togliatti al contrario vede di buon occhio. Fatto sta che la giovane redazione (fra gli altri Alfredo Reichlin, Luigi Pintor, Arminio Savioli, Paolo Spriano, Maurizio Ferrara, Luciano Barca, Davide Lajolo) con le sue novità e i suoi “cedimenti borghesi” nel racconto del Paese fa dell’Unità un giornale di massa, nazional-popolare nel senso più nobile del termine, un giornale che parla molto di politica e di lavoratori, ma anche di cronaca, cinema, musica, costume, sport (Alfonso Gatto, poetico narratore di ciclismo), satira, moda e donne. Un giornale che, nel delirante oscurantismo democristiano del tempo che censura tutto con apposita commissione (nel cinema, l’arte più popolare, la censura andreottiana offende non solo Carlo Lizzani e Luchino Visconti, comunisti iscritti al partito, ma anche Rossellini, De Sica, Risi, Fellini, Germi, Lattuada, perfino Totò…), attira spiriti liberi non necessariamente comunisti. Ed ecco il capolavoro del compagno Pietro, la direzione di un quotidiano dichiaratamente comunista eppur garanzia di libertà di espressione, fedele alla linea politica ufficiale eppur sensibile agli americanismi di moda. Palmiro Togliatti osserva con piglio severo ma benevolo quella redazione di “scapestrati”, con quotidiane e sarcastiche osservazioni vergate su bigliettini bacchetta ed esorta i redattori, richiama e dissente dai loro pezzi così come acconsente e si congratula. Ma li lascia fare. Lascia crescere quel laboratorio di idee fatto da ragazzi vivaci e squattrinati (forse solo “Il Giorno”, a cavallo fra gli anni ‘60 e ‘70, potrà avvicinarsi allo stile letterario di quella “Unità”). Se lo chiamavano “il migliore” uno dei motivi era che Togliatti aveva capito prima di altri che il partito comunista di massa richiedeva un’informazione di massa, una comunicazione, diremmo oggi, adatta alla condizione proletaria dei lettori e alle loro esigenze di istruzione non per forza ortodossa e non disdegnante lo svago. Ovviamente l’organo ufficiale del PCI fa inchieste importanti, una condotta proprio da Ingrao indaga sulle condizioni dei braccianti calabresi, che il direttore va a trovare dopo la strage di Melissa, piccolo paese vicino a Crotone dove la polizia aveva sparato sugli occupanti le terre incolte uccidendo due uomini e una donna. Appassionato e crudo il resoconto di Ingrao, che inaugura la stagione delle inchieste sociali dell’Unità, fatte soprattutto al sud dove il progresso tecnico e civile sembra non poter arrivare e larghe fasce di popolazione vivono ancora in condizioni semi-primitive. Finalmente il partito, grazie al suo giornale, si apre al sud, va a conoscere il sud che i dirigenti del nord non conoscono e così guadagnando voti. L’Unità comincia a essere venduto anche al sud, spesso letto da compagni istruiti a contadini analfabeti. Più di quattrocentomila copie giornaliere vende l’Unità, a dimostrazione che quel modo di intendere il partito e la lotta piace ai militanti e ai simpatizzanti. La precisazione “sta scritto sull’Unità” diventa la necessaria e convinta chiosa a ogni discorso fra compagni, la conferma incontestabile di una verità scritta nella bibbia del comunismo italiano. Togliatti difende il giornale dagli attacchi interni ed esterni, dai dirigenti più vecchi che accusano l’Unità di parlare poco della Russia e del partito così come dagli strali dal Cominform, il gran controllore della stampa comunista. Quando l’organo di informazione dei partiti comunisti e laburisti europei convoca Ingrao nella sua sede di Bucarest per redarguirlo duramente, il direttore ci resta molto male e al suo ritorno in Italia offre a Togliatti le sue dimissioni. Il segretario taglia corto: “Continuate a fare come state facendo”. E Ingrao continua nella sua indipendenza. Si arriva così al 1953, alla legge truffa e alle proteste di piazza. La polizia di Scelba picchia duro sui manifestanti, e pure Ingrao ne assaggia i manganelli. Una sera di giugno infatti, il direttore Ingrao va in giro per via del Tritone (a Roma) per appurare quello che sta succedendo fra forze dell’ordine e militanti del partito. Trova una zuffa e armato di tesserino di deputato (quale è) tenta di salvare i compagni dall’ennesimo pestaggio, ma per tutta risposta si vede arrivare una randellata sulla testa che gli apre una ferita. Sanguinante, accompagnato dal cronista parlamentare Maurizio Ferrara (il papà di Giuliano) subito si reca in parlamento a dar plastico esempio all’aula della democrazia dei metodi usati dal governo. Altri tempi, altre passioni, altre teatralità politiche. Qualche mese prima è morto Stalin, l’eroe della vittoria sul nazismo, e Ingrao ha fatto un titolo enorme per celebrarne la grandezza. Il compagno Pietro, come (quasi) tutti i compagni occidentali ancora non sapevano dei crimini e delle nefandezze del baffone georgiano che sempre doveva arrivare per mettere a posto le cose. E nel 1956, quando il 5 giugno il New York Times pubblica il rapporto segreto di Krusciov su Stalin, Ingrao vorrebbe affrontare di petto l’argomento ma sbatte contro il silenzioso ostracismo di Togliatti. Così l’Unità mantiene una posizione cauta, timorosa, nonostante le lamentele dei redattori. Solo il 21 marzo del 1957 Ingrao in un editoriale trova le parole e, chissà, forse pure l’autorizzazione di Togliatti, per ammettere gli errori commessi da Stalin e per aprire una “via italiana al socialismo…sul terreno della democrazia politica e degli istituti parlamentari”. Sembra poco mentre poco non è: l’editoriale, nei modi e nelle forme tipiche del burocratese comunista, segna il distacco dallo stalinismo e dalle idee di rivolta armata. Il PCI è un grande partito di massa democratico, che ha combattuto per la libertà e nella libertà deve rimanere. E tale bisogno di libertà viene ulteriormente e drammaticamente ribadito nei giorni dell’invasione dell’Ungheria coi carri armati dell’armata rossa. Ingrao, all’inizio, si schiera “Da una parte della barricata a difesa del socialismo”, come intitola un suo famoso editoriale. Mal glie ne incoglie però, la redazione si rivolta contro quella evidente presa di posizione acritica. Ingrao cerca risposte a casa di Togliatti, che gelidamente lo licenzia. “Il Manifesto dei centouno”, con cui redattori e collaboratori dell’Unità prendono le distanze dalla tremenda invasione sovietica, fa infuriare Togliatti ma spinge Ingrao a vederci chiaro. Il direttore manda a Budapest il lucano Alberto Jacoviello, inviato di punta dell’Unità, che osserva da vicino i fatti, li vive, li analizza, e non può condannare la rivoluzione ungherese che non può liquidarsi come controrivoluzione borghese. I suoi pezzi vengono “corretti”, “tagliati”, “mozzati”, ma la verità si capisce. Alla fine del burrascoso 1956 Ingrao si dimette dalla direzione del giornale. I motivi possono essere molteplici, invero mai chiariti. Pietro sicuramente è deluso dagli ultimi avvenimenti, dal dovere insopprimibile di dire le cose e nello stesso tempo di non allontanarsi troppo dalla linea del partito. Va a lavorare nella segreteria del partito dove comincia un’altra vita…
Ma a noi interessa l’Ingrao giornalista, quello che prese l’Unità e ne fece il giornale del popolo e degli artisti, del cambiamento e della democrazia, dell’impegno e delle feste. Il grande giornale della Sinistra italiana.