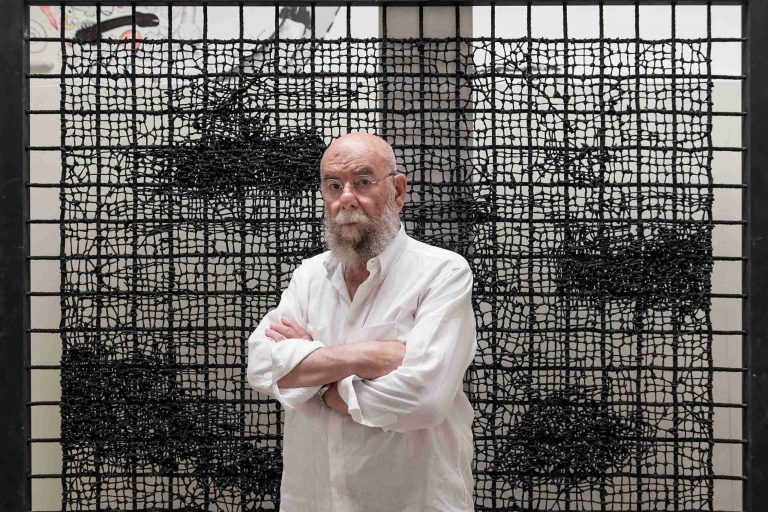Robert Billot, avvocato ambientalista, che ha intentato, a partire dagli anni 90, una causa contro un’azienda colosso della chimica per l’inquinamento costante delle acque (mondiali) con una sostanza pericolosa per la salute (Dark waters, 2019)
Lual Mayen, creatore di un videogioco a tema pace, di cui parte dei ricavati viene devoluta a ONG che si occupano di aiutare i rifugiati politici (Salaam)
Katherine Johnson, matematica afroamericana, che ha lavorato ai programmi spaziali della NASA a partire dagli anni 50 (Hidden figures, 2016)
Chiara Ferragni, imprenditrice e influencer italiana, ideatrice di un brand di moda, che ha contribuito a un nuovo modo di fare marketing e partecipato alla realizzazione di un documentario su sé stessa (Unposted, 2019)
Verosimilmente alcuni dei nomi sopra citati non dicono molto senza dare un’occhiata al riferimento in corsivo e tra parentesi, titoli di film o progetti che hanno permesso di far conoscere ai più i protagonisti delle frasi. Probabilmente uno dei nomi invece, sì, risulta riconoscibile anche senza la parte finale della frase scelta per introdurlo.
Se non oggettiva credo potrebbe definirsi più o meno “universalmente riconosciuta” una gerarchia di valore morale dei contributi sopra nominati e credo ancora che il modificare una strategia di marketing, per quanto innovativo per il campo che ha accolto l’idea, possa essere considerato, in modo abbastanza unanime, ai piedi di questa piramide.
Allora sorge spontanea una domanda: cosa ricordiamo delle persone che ricordiamo e perché decidiamo di ricordarne alcune e dimenticarne altre?
Nella crescita ogni persona, consciamente o inconsciamente, individua modelli a cui ispirarsi per il proprio percorso di vita, dipendentemente dall’ambito o specializzazione del caso. Sarebbe, senza dubbio, superflua una disquisizione sui tempi moderni e l’alienazione creata dall’abuso di nuove tecnologie e social media.
Data l’alienazione come base, quindi, oggi più di ieri, pare ovvio che la scelta dei modelli diventi in qualche modo filtrata da un velo, nella quale l’idealizzazione, già tipicamente umana, viene affiancata da una non-presenza socialmente accettata per le persone che si riconoscono come parte della vita gli uni degli altri, per accentuarsi, in modi fanatici e ciechi, per i modelli da seguire, i quali per natura fanno parte della nostra vita concettuale, ma molto spesso non fisica.
Inevitabilmente, l’uomo moderno è forgiato da una società basata sull’American dream, dove tutti possono ottenere tutto, indipendentemente dalle condizioni socio-economiche di partenza.
Ideologia nata nella prima metà del secolo scorso e sviluppatasi nella seconda, ha coinvolto, nella sua evoluzione una pluralità di individui, che ha basato la sua concezione di vita sulla massima hard working for a better life, in una società che ha visto, in molti casi, la riuscita di imprese ambiziose a partire da condizioni più che modeste.
Superate le teorie delle affermazioni aforistiche, si potrebbe passare però all’analisi concreta delle differenze che hanno caratterizzato il sogno americano nel contesto della sua nascita e l’evoluzione che lo ha portato ai giorni nostri: oggi siamo distratti.
Le nuove generazioni sono quelle del “tutto e subito”, quelle che colgono i raccolti seminati dai genitori e dai nonni nei decenni passati, ignorando ciò di cui ha avuto bisogno il raccolto per diventare tale.
Ecco che la massima su cui si basa il sogno americano, nell’epoca del consumismo più sfrenato, che pone sempre un velo sull’altra faccia della medaglia, viene deviata in una catastrofica castrazione che la traduce semplicisticamente in: for a better life.
A difendere il raccolto senza semina subentra poi la reattanza, che aiuta a negare non il velo, ma l’esistenza dell’altra faccia della medaglia con giustificazioni che vanno dal cambio dei tempi e delle opportunità, all’intelligenza e alla furbizia delle generazioni moderne a discapito di quelle passate.
La ricerca di un modello a cui ispirarsi per migliorare la propria vita – a volte prima o a prescindere dall’idea di migliorare sé stessi – si concretizza nella ricerca di un sogno, in bilico tra irraggiungibile e alla portata di tutti.
Irraggiungibile per la natura intrinseca del sogno: la distanza tra la condizione reale e quella agognata pone le basi per un percorso ideale, minato, il più delle volte, da insicurezze, paure ed autosabotaggio, non marginali.
Alla portata di tutti perché spesso sono i pari ad essere ammirati. Risultato anche di un’evoluzione e di una distorsione delle buone intenzioni della peer-education, dove a regnare è l’imporsi volontario e manipolato di chi vuole e riesce, che sfocia, nelle sue estreme conseguenze, in marketing mascherato da opinione.
Con il risultato che la peer-education in mano ad alcuni è come Nietzsche nelle mani dei nazisti.
La miriade di stimoli che bombarda tutti e la priorità accordata alla gratificazione immediata non aiuta nella scelta di una guida.
Chissà se il sogno americano serva come modello da seguire o come un esempio di come una buona idea possa andare fuori strada.