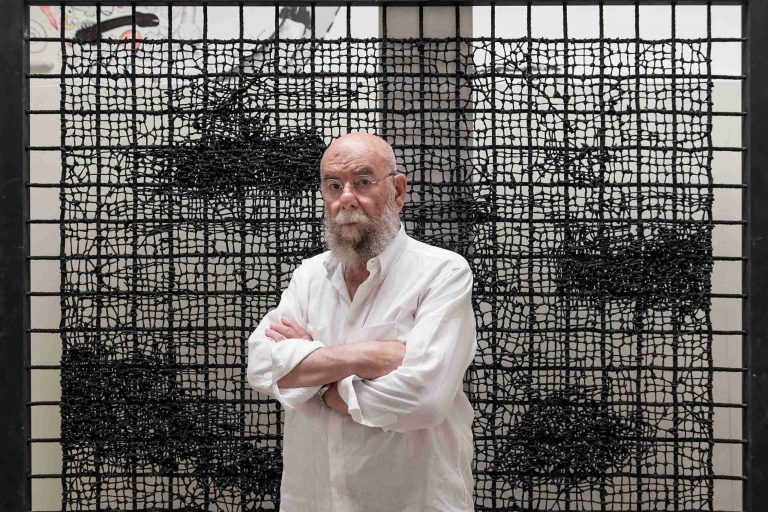Cosa unisce “Silence”, l’ultimo film di Martin Scorsese e “The Young Pope”, la discussa serie di Paolo Sorrentino?
Ma andiamo con ordine, partendo dall’ultima fatica di Scorsese. Silence è il viaggio di due gesuiti portoghesi, interpretati da Andrew Garfield e Adam Driver che salpano alla ricerca di Padre Ferreira (Liam Neeson) loro mentore partito per una missione di evangelizzazione in Giappone ma uno dei due – Padre Rodrigues – finisce per smarrire la propria fede.
Analogamente, nella serie tv del premio Oscar italiano, tutto ruota, sostanzialmente, attorno la storia di un Papa che non crede in Dio.
Ma da dove viene tutta quest’urgenza di volgere la cinepresa verso l’Altissimo? Quanto c’entra la crisi in Medio Oriente, i flussi migratori che negli ultimi anni hanno investito l’Europa e il terrorismo di matrice islamica?
La storia degli ultimi anni ci ha spinti a fare i conti con il nostro mondo aprendo con forza uno spazio per una riflessione su Dio non solo nelle nostre anime, ma anche sulle pagine dei nostri giornali e sui nostri schermi.
Silence getta un ponte lunghissimo dal Giappone governato dagli shogun del XVII all’occidente di oggi e con il sussurro di una preghiera ci racconta di noi cristiani, usando la cultura nipponica come lente privilegiata per guardare, ma soprattutto guardarci.
La vocazione alla religiosità di Scorsese affronta in modo dialettico il rapporto tra buddismo e cattolicesimo: la cultura e la religione giapponesi vengono rappresentate nei loro caratteri peculiari mostrando soprattutto l’apertura al dialogo con il diverso che spinge a chiederci, quanto siamo aperti noi cristiani d’oggi?
Ancora una volta, il regista italo-americano mostra il proprio talento costruendo per sottrazione una narrazione di quasi tre ore che non appesantisce lo sguardo né annoia la mente.
Quando può Scorsese fa volentieri a meno di colonna sonora, dialogo, azione, ma non della violenza che si compie sui corpi martoriati dei contadini convertiti alla nuova dottrina.
Una sottrazione che si rispecchia nel destino del protagonista che nel corso della storia è costretto a rinunciare a tutto pur di avere salva prima la vita e poi l’anima.
L’unica cosa che sopravvive a questa graduale ma violenta spoliazione è l’immagine.
Intesa sia in senso cinematografico, e in questo senso Silence si fonda sul potere dell’immagine, sia in senso religioso, mostrando come il cristianesimo si fondi sull’iconografia.
Il silenzio è principio e fine della storia di Rodrigues: è il silenzio di Padre Ferreira che porta i due gesuiti ad intraprendere il loro pericoloso viaggio, è il silenzio di Dio – ovvero l’assenza della sua manifestazione – ad aprire una ferita profonda nel giovane prete che sente l’incrinarsi la propria fede sotto il peso della sofferenza, e infine, è nel silenzio della rinuncia che Rodrigues vivrà il rinnovo e il consolidamento del proprio giuramento a Gesù.
La fede ritrovata è totalmente diversa da quella che l’aveva spinto a partire, una fede che non si esprime e non è veicolata da crocifissi, immagini, rosari venerati al pari di totem e oggetti magici, ma che abbandona ogni adesione formale al cristianesimo inteso come istituzione per trovare finalmente la verità nell’ intimità del proprio spirito. O forse no.
Forse, Silence è la storia di due gesuiti che fanno un viaggio per ritrovare il loro padre spirituale, viaggio che pagano con la vita e con lo smarrimento della propria anima.
Visto così, il film è la storia di una tortura, un lunghissimo stillicidio della fede di un uomo.
E anche dello spettatore più impaziente e meno concentrato.
In questo senso leggere un film somiglia molto alla pratica della tasseomanzia.
Ognuno, ci vede quello che vuole.