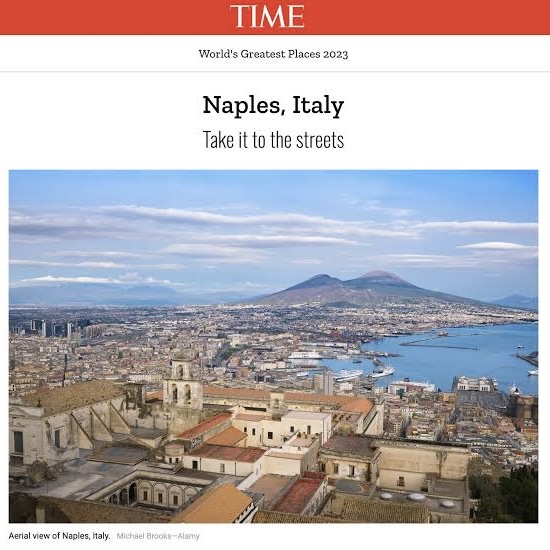Quando si parla di Napoli, o almeno quando i napoletani parlano di Napoli, la associano generalmente alla città del sole. Questo è giusto, ma Napoli ha anche un forte aspetto esoterico, buio, celato nei misteriosi vicoli e nelle leggende e storie di fantasmi tramandate dal popolo, di generazione in generazione. Già il fatto che a Napoli esista un percorso sotterraneo (oltre a Napoli sotterranea e al Tunnel Borbonico, da non dimenticare gli scavi di San Lorenzo maggiore, una delle più antiche chiese di Napoli, dove si racconta che si siano incontrati Boccaccio e Fiammetta), specularmente a quello alla luce del sole, ci fa capire quanta importanza questa città abbia dato da sempre alla cultura “altra”, buia e spettrale. La leggenda di Donn’Albina, Donna Romita e Donna Regina, figlie del barone Toraldo, nobile del Sedile del Nilo, ci viene raccontata da Matilde Serao nel suo libro “Leggende napoletane”.
Quando si parla di Napoli, o almeno quando i napoletani parlano di Napoli, la associano generalmente alla città del sole. Questo è giusto, ma Napoli ha anche un forte aspetto esoterico, buio, celato nei misteriosi vicoli e nelle leggende e storie di fantasmi tramandate dal popolo, di generazione in generazione. Già il fatto che a Napoli esista un percorso sotterraneo (oltre a Napoli sotterranea e al Tunnel Borbonico, da non dimenticare gli scavi di San Lorenzo maggiore, una delle più antiche chiese di Napoli, dove si racconta che si siano incontrati Boccaccio e Fiammetta), specularmente a quello alla luce del sole, ci fa capire quanta importanza questa città abbia dato da sempre alla cultura “altra”, buia e spettrale. La leggenda di Donn’Albina, Donna Romita e Donna Regina, figlie del barone Toraldo, nobile del Sedile del Nilo, ci viene raccontata da Matilde Serao nel suo libro “Leggende napoletane”.
Il padre delle tre sorelle, vedovo della nobildonna Gaetana Scauro, ottenne come speciale favore dal re Roberto d’Angiò che sua figlia maggiore,Donna Regina, potesse, sposandosi, conservare il suo nome di famiglia e trasmetterlo ai propri figli. Il barone morì nel 1320 quando Donna Regina aveva diciannove anni, Donna Albina diciassette e Donna Romita quindici. La primogenita era bellissima e austera, Donna Albina era amabile e sorridente, e Donna Romita aveva un carattere molto volubile. Roberto D’Angiò destinò in sposo a Donna Regina Don Filippo Capece, cavaliere della corte napoletana. Un giorno mentre Donna Regina teneva tra le mani un libro di preghiere senza, però, leggerlo, le si rivolse supplichevole la sorella Donna Albina parlandole della sua preoccupazione per la sorellina più piccola, la quale soffriva terribilmente per le prime pene d’amore. Regina, scandalizzata e furibonda, pretese di conoscere il nome dell’uomo e, quando Albina, tremante ed appassionata, le confessò quello del cavaliere Don Filippo, ella comprese con disperazione che anche Albina lo amava. Arrivò la Pasqua e le due sorelle minori si presentarono a Regina vestite molto semplicemente per implorare il suo perdono e per chiederle di dare il consenso per la propria clausura in convento. Regina allora fece sapere di aver preso da tempo la stessa decisione in quanto resasi conto che Don Filippo la odiava. Donna Regina si alzò, prese lo scettro d’ebano, borchiato d’oro e lo spezzò in due pezzi e, rivolgendosi al ritratto dell’ultimo barone Toraldo gli disse, inchinandosi: – Salute, padre mio, la vostra nobile casa è morta. In omaggio a questa triste storia d’amore, troviamo a Napoli tre luoghi con i nomi delle tre sorelle: via Donnalbina in prossimità di Piazza Matteotti, Via Donnaromita e Largo Donnaregina in prossimità di Via Duomo
. Matilde Serao ci parla anche di un’altra storia nel suo libro, e cioè quella relativa al Palazzo Donn’Anna, un grosso edificio cinquecentesco che si erge nel mare di Posillipo. Fu ereditato da donn’Anna Carafa nel 1636, quando sposò il viceré spagnolo Filippo Ramiro Guzman, duca di Medina. Nel 1642 iniziarono i lavori per l’edificio, diretti da Cosimo Fanzago, e durarono per oltre due anni, ma poi furono interrotti e mai più ripresi, e Matilde Serao ci descrive così il palazzo: “Non è diroccato, ma non è stato mai finito, le sue finestre alte, larghe, senza vetri, rassomigliano ad occhi senz’anima. Di notte il palazzo diventa nero e cupo e sotto le sue volte s’ode solo il fragore del mare. Tanti anni fa, invece, da quelle finestre splendevano le vivide luci di una festa, attorno al palazzo erano ormeggiate tante barchette adorne di velluti e di lampioncini colorati. Tutta la nobiltà spagnola e napoletana accorreva ad una delle magnifiche feste che, l’altera Donna Anna Carafa, moglie del duca di Medina Coeli, dava nel suo palazzo”. Si racconta che Anna fosse stata l’amante di Gaetano di Casapesenna, e che, durante una festa, questi fosse stato baciato da donna Mercede de las Torres, nipote di Anna – mentre recitava la parte di una schiava innamorata del suo padrone – con un tale trasporto, che Anna si ingelosì, e, tra gli applausi del resto del pubblico, impallidì improvvisamente. Le due donne nei giorni successivi litigarono e un giorno donna Mercede scomparve, e nemmeno Gaetano di Casapesenna, nonostante la cercasse ovunque, riuscì a trovarla; si diffuse la voce che era stata presa da improvvisa vocazione religiosa e si era rinchiusa in convento. La leggenda vuole che lo spettro di Donn’Anna appaia di tanto in tanto nel palazzo posillipino; altri sostengono che le oscure presenze siano da ascrivere alle anime in pena di Gaetano di Casapesenna e donna Mercede. Infine, c’è chi dice che nella struttura appaia il fantasma della regina Giovanna I d’Angiò.
Il personaggio di Maria D’Avalos, invece, affascinò il poeta Torquato Tasso, che dedicò quattro sonetti all’amore tra lei e Fabrizio Carafa “In morte di due Nobilissimi Amanti” : Piangete o Grazie, e voi piangete Amori, feri trofei di morte, e fere spoglie di bella coppia cui n’invidia e toglie, e negre pompe e tenebrosi orrori. Piangete o Ninfe, e in lei versate i fiori pinti d’antichi lai l’umide foglie e tutte voi che le pietose doglie stillate a prova e lacrimosi odori. Piangete Erato e Clio l’orribil caso e sparga in flebil suono amaro pianto in vece d’acque dolci o mai Parnaso. Piangi Napoli mesta in bruno ammanto, di beltà di virtù l’oscuro occaso e in lutto l’armonia rivolga il canto. Il Tasso fu amico del principe Carlo Gesualdo, finché questi non scoprì che il poeta aveva dedicato questi versi all’amore tra sua moglie e l’amante. Il principe Carlo Gesualdo nacque a Venosa (PZ) l’8 marzo 1566 da Fabrizio e Geronima Borromeo, e, dopo la morte del fratello maggiore, ereditò la responsabilità della perpetuazione del casato. Studiò musica e fu musicista raffinatissimo ed eccezionale precursore della musica moderna. Nel 1586 Carlo sposò sua cugina di primo grado, Maria d’Avalos, una delle donne più belle e sensuali di Napoli, figlia del conte di Montesarchio. All’epoca i matrimoni tra parenti erano una consuetudine per l’alta nobiltà, così da aumentare le ricchezze invece di disperdere il patrimonio familiare. Per Maria erano le terze nozze; si diceva che Federigo, il primo marito, fosse morto per la troppa attività di letto. Dalla nuova unione nacque un figlio, Emanuele. Ma la differenza di età, gli interessi culturali diversi, il fascino inesistente del principe, il matrimonio imposto da interessi familiari, portarono ben presto la bella Maria fra le braccia di uno degli uomini più belli della città: Fabrizio Carafa, duca d’Andria, detto per la sua avvenenza “l’arcangelo”. Per molto tempo i due amanti continuarono a vedersi e a coltivare il loro amore, all’insaputa del principe. Tutti tranne Carlo sapevano dei due, e quando suo zio, Giulio, da sempre innamorato dal nipote, gli svelò la tresca, egli finse di partire per una battuta di caccia agli Astroni (riserva nei Campi Flegrei) e si appostò nelle cantine del suo palazzo con tre fidati sicari, che uccisero barbaramente entrambi gli amanti, appena li sorprese nel pieno della notte nel talamo nuziale.
Il principe rimase nell’anticamera; solo quando tutto fu compiuto si accanì col suo pugnale, prima sul cadavere del duca, quasi volesse cancellare la sua bellezza, e poi sul ventre della moglie. I corpi straziati e nudi degli amanti furono esposti sul portone di casa, per mostrare alla città che l’onore del principe di Venosa era salvo. Carlo si rifugiò poi nel feudo di famiglia di Gesualdo, per paura di una eventuale vendetta da parte della famiglia Carafa, e lì si tormentò per i misfatti e compose soltanto musica sacra, quasi come prova di espiazione. Si dice che dal giorno successivo all’uccisione dei due amanti il fantasma della bellissima Maria D’Avalos vaghi tutte le notti per le strade buie di Piazza Sam Domenico Maggiore, emettendo strazianti lamenti in cerca dell’amante perduto e lasciando brividi di terrore alle persone che li sentono.
L’ultima leggenda che raccontiamo è quella del personaggio esoterico più noto, oltre che più temuto, a Napoli: il cosiddetto “munaciello”. Il termine“munaciello” in napoletano significa “piccolo monaco” e identifica un piccolo spiritello che si comporta sempre in modo imprevedibile e sul quale sono sorte infinite leggende e detti popolari. Ci sono due versioni dell’origine di questa storia. La prima si riferisce ai pozzari, gli antichi gestori dei pozzi d’acqua, che potevano facilmente intrufolarsi nelle case altrui tramite i cunicoli del pozzo e fare i dispetti quando i proprietari non li pagavano per i loro servizi. Probabilmente questa versione è stata inventata dalla fantasia popolare per dare al munaciello caratteristiche “bonarie”. Esiste un’altra versione, per la quale il munaciello sarebbe una presenza demoniaca in veste di frate, alla ricerca di un’anima da rubare. Anche questa storia ci viene raccontata in Leggende napoletane da Matilde Serao, che associa la figura del munaciello a un personaggio veramente esistito, nel 1445, durante il regno di Alfonso V d’Aragona, e la riconduce all’amore impossibile descritto dalla tradizione poetica e musicale napoletana, tra Caterinella Frezza, figlia di un ricco mercante di panni, e il garzone Stefano Mariconda. Fortemente contrastata soprattutto dalla famiglia di lei, la coppia ricorreva ad incontri clandestini durante la notte, cui il giovane garzone si recava percorrendo un pericoloso sentiero sui tetti di Napoli. Un giorno Stefano fu assalito e gettato nel vuoto, sotto gli occhi della fidanzata. Dopo che la salma del giovane fu inumata, Caterinella, in stato interessante, chiese ed ottenne di rinchiudersi in un convento della zona, dove diede alla luce un bambino piccolo e deforme, le cui condizioni non mutarono durante la crescita, nonostante la madre avesse chiesto alla Madonna una grazia. Iniziò a vestirlo con un abito bianco e nero da monaco. Gli furono attribuiti da subito poteri soprannaturali benevoli o malevoli: se vestito con un cappuccio rosso, sarebbe stato di buon augurio, se con un cappuccio nero, avrebbe presagito terribili sventure. Dopo la morte della madre, la situazione peggiorò ulteriormente, e gli vennero attribuite ogni sorta di avvenimenti sfavorevoli, dalle malattie alle nuove tasse, e gli assalti anche fisici alla sua persona peggiorarono.
Infine, il munaciello scomparve misteriosamente, e la voce popolare fu che fosse stato portato via dal diavolo. La Serao riporta però che qualche tempo dopo furono ritrovate in una cloaca delle ossa che avrebbero potuto essere quelle del nano, ed avanza l’ipotesi che i parenti Frezza avessero alla fine deciso di assassinarlo: “Chiedete ad un vecchio, ad una fanciulla, ad una madre, ad un uomo, ad un bambino se veramente questo munaciello esiste e scorazza per le case, e vi faranno un brutto volto, come lo farebbero a chi offende la fede. Se volete sentirne delle storie, ne sentirete; se volete averne dei documenti autentici, ne avrete. Di tutto è capace il munaciello…” Quasi in contrapposizione con la figura del monaciello abbiamo quella della bella ‘Mbriana, che viene identificata con lo spirito della casa: si presenta per pochi attimi accanto alla tenda e ha un’espressione serena e solare (il suo nome viene dal latino “meridiana”, l’ora più luminosa del giorno). La bella ‘Mbriana era una principessa che vagava da sola per i vicoli della città, come un’ombra, aveva perso la ragione a causa di un amore infelice. Il re, per proteggerla, ricompensava con doni anonimi le case in cui la giovane fanciulla veniva accolta. Oltre ad essere bella, si dice che la bella ‘Mbriana sia anche molto capricciosa, legata alla pulizia e all’ordine in casa, e che protegga chi ama la propria casa, ma si vendichi di chi ne parla male. Per questo come usanza popolare c’è il fatto di non lamentarsi mai della propria casa all’interno di essa, per non farsi sentire dalla bella ‘Mbriana. A questa figura viene associato anche il geco, l’animaletto che nelle sere d’estate dà la caccia agli insetti vicino le lampade, e che per il suo legame con questo personaggio, non viene mai cacciato o disturbato dai napoletani.